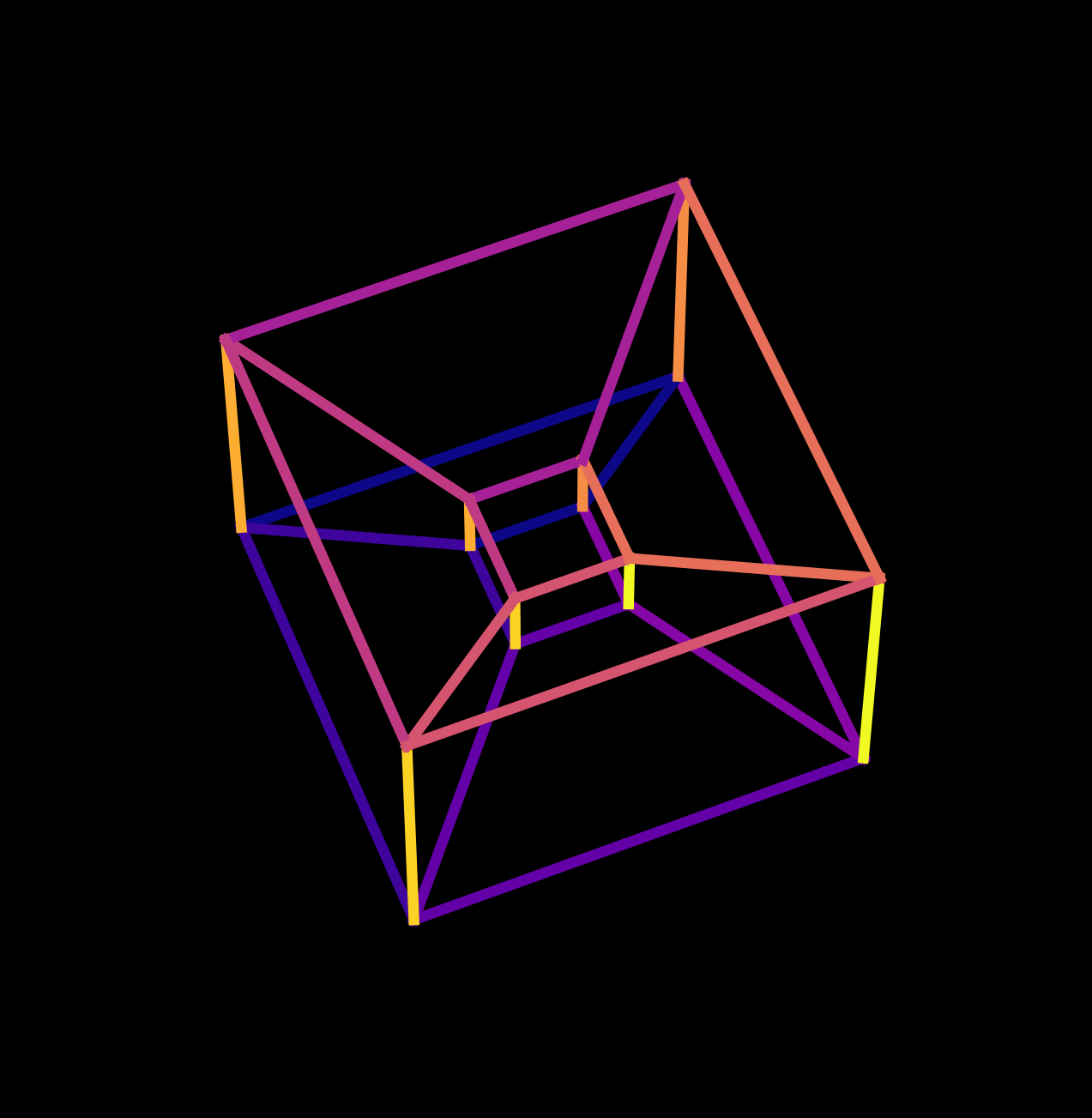Emotional Lens: Joy – Article 5 of 6
Introduzione
La gioia è un’emozione primaria di valenza positiva, universalmente riconosciuta e associata a una condizione di benessere psicofisico. Nonostante venga spesso considerata l’emozione positiva per eccellenza, la sua natura è complessa e sfaccettata, presentandosi in forme che variano per intensità, durata e modalità espressiva. La sua manifestazione avviene in risposta a stimoli, eventi o situazioni percepite come positive, tra cui la realizzazione di risultati desiderati personali, il raggiungimento di obiettivi prefissati, il superamento di difficoltà, l’apprezzamento di esperienze estetiche o la condivisione di momenti significativi con altri individui. In questo contesto, essa può emergere come risposta immediata a esperienze di gratificazione oppure manifestarsi nelle fasi iniziali di un processo di soddisfazione, per poi evolvere trasformandosi progressivamente e stabilizzandosi in una condizione di benessere meno intensa ma più duratura.
Dal punto di vista evolutivo, tale emozione ha un’importante funzione adattiva, poiché rafforza i comportamenti che portano a esperienze favorevoli, facilita le interazioni sociali e promuove il senso di connessione con gli altri. Inoltre, favorisce la cooperazione, incentiva il supporto reciproco e intensifica il legame interpersonale legato alle esperienze condivise, nonché la qualità stessa delle relazioni interpersonali e della sfera personale. D’altro canto, la sua funzione non si limita a un rinforzo motivazionale, ma si estende, parallelamente, anche alla regolazione emotiva complessiva, che non solo contribuisce a bilanciare stati affettivi negativi, ma supporta anche la resilienza dell’individuo nei confronti delle difficoltà.
Tuttavia, proprio in virtù della sua funzione adattiva, la gioia non presenta un’uniformità espressiva assoluta. Sebbene essa venga spesso percepita come un’emozione immediata e spontanea, tale stato emotivo può assumere configurazioni diverse a seconda del contesto, del temperamento individuale e delle norme socioculturali. Alcune sue manifestazioni si presentano in forme più espansive e coinvolgenti, caratterizzate da un’attivazione fisiologica elevata, come accade nelle risate o nei momenti simili all’euforia. In altri casi, la gioia si esprime in modalità più contenute, come nei sorrisi sottili e nelle espressioni legate a stati di soddisfazione interiore, che, pur non avendo una componente esplosiva, riflettono comunque un senso di appagamento. Dal punto di vista della mimica facciale, tale emozione coinvolge diversi distretti del volto, tra cui la regione periorale e quella perioculare, risultando in una configurazione facilmente distinguibile. Tuttavia, le variazioni nella sua espressione possono essere influenzate da fattori culturali e individuali. Inoltre, alcune concezioni filosofiche e tradizioni di pensiero concepiscono il benessere non tanto come la ricerca costante di momenti gioiosi, quanto come il mantenimento di un equilibrio complessivo tra le diverse sfumature della vita emotiva.
L’analisi di questa emozione non si limiterà alla sua mimica facciale, ma prenderà in esame anche il ruolo che essa ricopre a livello socioculturale e nei meccanismi neurobiologici che la sottendono.
La percezione culturale della gioia e il suo impatto

La gioia è spesso considerata l’emozione per eccellenza, un’esperienza desiderabile e centrale nella costruzione del benessere individuale. Nella cultura contemporanea, il suo ruolo è stato progressivamente enfatizzato, fino a diventare non solo un obiettivo esistenziale, ma anche un parametro con cui misurare il valore della propria vita. Questa sovraesposizione ha portato a una visione distorta della gamma emotiva umana, in cui le emozioni più complesse o considerate negative tendono a essere marginalizzate o percepite come ostacoli da superare piuttosto che come elementi naturali dell’esperienza soggettiva. Questa dinamica non è priva di conseguenze. L’elevazione della gioia a stato privilegiato ha contribuito a ridefinire il modo in cui gli individui percepiscono e gestiscono le proprie emozioni, influenzando il comportamento, le scelte di vita e persino le strutture sociali. Il modo in cui essa è culturalmente promossa, e talvolta imposta, può incidere profondamente sulla regolazione emotiva e sulla costruzione dell’identità personale, favorendo atteggiamenti di evitamento rispetto a stati affettivi meno desiderabili e dando luogo a fenomeni come la positività tossica o la ricerca compulsiva di stimoli gratificanti.
Nelle società contemporanee, la gioia è spesso considerata l’emozione cardine, tanto da essere elevata a ideale emotivo e sociale. Il suo valore è amplificato dai modelli culturali dominanti, che la promuovono da stato desiderabile a status primario, da raggiungere e mantenere, fino a permeare l’esistenza. Attraverso media, pubblicità e narrazioni collettive, si è diffusa l’idea che la felicità – spesso intesa come un continuo stato di gioia – rappresenti il fine ultimo della vita. Questa concezione, radicata nel pensiero occidentale moderno, ha contribuito a costruire un immaginario in cui il benessere emotivo è misurato in base alla frequenza e all’intensità dei momenti gioiosi, trascurando la complessità dell’esperienza affettiva umana. Tale enfasi ha portato, di conseguenza, a una svalutazione implicita di altre gamme dello spettro emozionale. Emozioni come tristezza, rabbia e paura, pur avendo un’importante funzione adattiva, vengono spesso percepiti negativamente e trattati come esperienze da evitare o reprimere. Questo atteggiamento si riflette in molteplici aspetti della vita sociale e personale, alimentando una cultura emotiva in cui l’espressione della vulnerabilità viene talvolta stigmatizzata. L’imperativo della felicità, che domina molte dinamiche sociali e individuali, può anche indurre le persone a evitare consapevolmente situazioni che potrebbero generare emozioni più complesse e a non riconoscere o accogliere stati emotivi di diversa valenza affettiva, rendendo più difficile un’elaborazione integrata e adattiva del proprio mondo interiore.
In questo contesto, la ricerca costante di esperienze piacevoli può influenzare significativamente il comportamento individuale, portando talvolta allo sviluppo di strategie compensative non sempre funzionali. L’industria del benessere, i social media e le pratiche di consumo enfatizzano l’importanza di coltivare momenti di gioia, ma in alcuni casi questa spinta può favorire forme di dipendenza comportamentale, come il consumo e lo shopping compulsivo, le dipendenze affettive, la ricerca ossessiva di gratificazioni istantanee, l’abuso di sostanze o una sovraesposizione ai social network in funzione della validazione esterna. In particolare, esistono numerosi stimolanti sintetici e sostanze psicoattive che inducono stati di piacere, euforia o estasi, spesso con un costo altissimo in termini di dipendenza e deterioramento della salute mentale e fisica. Tra questi si trovano gli stimolatori dopaminergici, tra cui le anfetamine, le metanfetamine e la cocaina, che aumentano i livelli di dopamina e intensificano la sensazione di gratificazione. Altre categorie di sostanze, invece, come gli oppiacei e gli oppioidi, tra cui l’eroina, la morfina e l’ossicodone, e gli agonisti del recettore NMDA, tra cui la ketamina e il destrometorfano (DXM), agiscono su sistemi neurochimici differenti, inducendo euforia e alterazioni dello stato di coscienza; mentre l’MDMA (ecstasy), che favorisce il rilascio di serotonina, dopamina e noradrenalina, presenta proprietà sia stimolanti sia allucinogene lievi e effetti empatogeni che generano euforia e amplificano la connessione emotiva e sociale. Anche i depressori del sistema nervoso centrale, come i barbiturici e le benzodiazepine, pur avendo effetti principalmente sedativi, possono generare dipendenza fisica, con sindromi di astinenza alla sospensione, e dipendenza psicologica, spesso legata al sollievo dallo stress e all’induzione di stati di benessere artificiale; inoltre, l’alcol, sebbene abbia inizialmente un effetto disinibente e possa generare una temporanea sensazione di benessere, alle dosi più elevate manifesta proprietà sedative, compromette le funzioni cognitive e motorie e aumenta il rischio di dipendenza e danni neurologici a lungo termine.
Inoltre, l’idea che essa debba permeare ogni aspetto della vita quotidiana può sfociare in una forma di positività tossica, ovvero nella tendenza a invalidare o minimizzare le emozioni negative, con il rischio di limitare l’espressione autentica dell’emozione, compromettere la capacità di tollerare il disagio, ostacolare lo sviluppo di strategie di coping efficaci e rendere più difficile affrontare situazioni di stress, frustrazione o altre esperienze negative in modo resiliente. Il modo in cui tale emozione viene vissuta ed espressa, tuttavia, non è universale, ma varia in base al contesto culturale. Alcune società, in particolare quelle individualiste, incentivano l’espressione aperta della gioia e ne enfatizzano la manifestazione esteriore. In questi contesti, la capacità di dimostrare entusiasmo ed energia positiva è spesso considerata una qualità desiderabile e associata al successo personale e professionale. Al contrario, nelle culture collettiviste, l’equilibrio emotivo e la moderazione nell’espressione affettiva vengono privilegiati rispetto alla manifestazione espansiva della gioia. In queste società, la regolazione emotiva risponde a norme sociali che promuovono la compostezza e l’armonia sociale, rendendo le sue manifestazioni eccessive meno frequenti o più controllate. Queste differenze culturali non solo influenzano il modo in cui essa viene espressa, ma incidono anche sulla percezione del suo ruolo nella vita individuale e sociale.
Basi neurobiologiche

La gioia, come ogni emozione, è il risultato di un complesso intreccio tra sistemi neurobiologici e processi cognitivi, in particolare, è mediata dall’attivazione di specifiche aree corticali, strutture sottocorticali e strutture allocorticali, dalla modulazione di neurotrasmettitori e dall’interazione con il sistema endocrino e autonomo. Sebbene venga spesso associata a una sensazione di benessere e gratificazione, la sua base neurobiologica rivela una dinamica articolata che coinvolge più circuiti neurali e risposte fisiologiche integrate.
All’interno del sistema limbico, il nucleo accumbens e l’amigdala svolgono un ruolo cruciale nella codifica della gioia. In particolare, in un quadro semplificato, il nucleo accumbens (NAc), una delle principali strutture sottocorticali del circuito della ricompensa, responsabile della sensazione di gratificazione e motivazione, modula la risposta dopaminergica ricevendo principalmente proiezioni dai neuroni dopaminergici dell’area tegmentale ventrale (VTA). L’amigdala, sebbene più comunemente associata alla paura e alla valutazione di stimoli negativi, partecipa alla modulazione dell’intensità e contribuisce al consolidamento mnesico dell’emozione. Parallelamente, la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) contribuisce alla regolazione della gioia, in quanto integra segnali provenienti dal sistema limbico, da ulteriori strutture sottocorticali, strutture allocorticali e aree corticali e adatta l’emozione in base al contesto situazionale. Studi di neuroimaging hanno evidenziato una maggiore attivazione di questa regione in individui che sperimentano emozioni positive in situazioni di interazione sociale e affiliazione.
Inoltre, la gioia è strettamente legata all’attività di diversi neurotrasmettitori, che modulano la percezione del piacere, il tono dell’umore e la connettività neuronale:
- Dopamina: fondamentale nel circuito della ricompensa, questa molecola è associata alla motivazione, alla sensazione di piacere e alla ripetizione di comportamenti gratificanti. Il suo rilascio nel nucleo accumbens è correlato all’esperienza di gioia derivante da successi personali, interazioni sociali e attività ludiche, sebbene il piacere in sé sia mediato anche da altri sistemi neurochimici. Inoltre, queste esperienze emotive consolidano i circuiti neuronali associati al piacere e alla ricompensa, modulati principalmente dal sistema dopaminergico, con una conseguente facilitazione dei meccanismi di apprendimento di comportamenti che favoriscono il benessere.
- Serotonina: coinvolta nella regolazione del tono dell’umore e nella stabilità emotiva, contribuisce a un senso di benessere più duraturo e meno dipendente da stimoli immediati.
- Noradrenalina: coinvolta nell’arousal e nella risposta allo stress, contribuisce anche alla sensazione di eccitazione positiva e all’energia associata a tale emozione, specialmente in situazioni di entusiasmo e novità.
- Ossitocina: spesso definita “ormone dell’affiliazione”, è cruciale nelle esperienze di gioia legate ai legami interpersonali, promuovendo la connessione emotiva e la fiducia reciproca. Tuttavia, il suo effetto dipende dal contesto e può anche rafforzare la distinzione tra il proprio gruppo e gli altri. Dal punto di vista neurochimico, l’ossitocina è un ormone peptidico che esercita prevalentemente un’azione neuromodulatoria attraverso meccanismi extrasinaptici; tuttavia, in specifici contesti sinaptici, può svolgere anche una funzione trasmettitoriale, legandosi ai recettori ossitocinergici localizzati sulla membrana postsinaptica.
L’attività di questi neurotrasmettitori non è indipendente, ma si inserisce all’interno di una rete neurochimica altamente integrata, nella quale ogni composto chimico contribuisce a modularne l’esperienza soggettiva. La dopamina e la noradrenalina, per esempio, interagiscono nella regolazione della motivazione e dell’eccitazione emotiva, mentre la serotonina e l’ossitocina giocano un ruolo chiave nel mantenimento di un senso di benessere stabile e nella costruzione di legami affettivi. Accanto ai neurotrasmettitori classici, anche i neuropeptidi oppioidi, come le endorfine — che svolgono prevalentemente una funzione neuromodulatoria mediata da un rilascio extrasinaptico, pur potendo occasionalmente esercitare un’azione trasmettitoriale —, prodotte principalmente dall’ipotalamo e dall’ipofisi anteriore, contribuiscono al suo vissuto, specialmente nei momenti di intensa gratificazione. Il loro rilascio, indotto da esperienze piacevoli quali il ridere, l’attività fisica e il contatto sociale, facilita una sensazione di piacere prolungato e attenua la percezione del dolore, rafforzando l’associazione tra determinate esperienze e il senso di benessere. In un quadro più ampio, tale emozione influisce positivamente su diverse funzioni cognitive, tra cui l’attenzione, la flessibilità mentale e la capacità di problem-solving. Stati emotivi positivi sono associati a una maggiore creatività e a un miglior adattamento alle situazioni nuove. Inoltre, l’attivazione del circuito della ricompensa favorisce la motivazione e la persistenza nel raggiungimento degli obiettivi.
Tuttavia, la risposta emotiva si manifesta anche attraverso risposte fisiologiche, che includono sia attivazioni sia inibizioni, mediate dal sistema nervoso autonomo. L’attivazione del sistema nervoso parasimpatico è tipicamente associata a stati di rilassamento e benessere, mentre una componente simpatica può essere presente nelle forme più intense di gioia, come l’euforia. In particolare si osservano:
- Variazioni cardiache: la gioia moderata è associata a una riduzione della frequenza cardiaca e a un aumento della coerenza della variabilità della frequenza cardiaca (heart rate variability, HRV), indicativo di un migliore equilibrio autonomico. Nei momenti di euforia, invece, si osserva un aumento transitorio della frequenza cardiaca, mediato da una maggiore attivazione del sistema nervoso simpatico.
- Risposta neuroendocrina: Il rilascio di ossitocina, sintetizzata nei nuclei sopraottico e paraventricolare dell’ipotalamo e immagazzinata nella neuroipofisi, avviene nel circolo sanguigno in risposta ai segnali ipotalamici, in coordinazione principalmente con l’attività del sistema nervoso parasimpatico. Al contrario, il cortisolo, principale ormone dello stress, è sintetizzato e rilasciato dalla corteccia surrenale sotto il controllo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). In particolare, il rilascio di CRH (ormone di rilascio della corticotropina) da parte dell’ipotalamo stimola l’adenoipofisi a secernere ACTH (ormone adrenocorticotropo), che a sua volta induce la sintesi e, successivamente, il rilascio di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali. Tuttavia, l’attivazione del sistema nervoso simpatico può amplificare questa risposta, potenziando il rilascio di CRH da parte dell’ipotalamo e stimolando direttamente la produzione di catecolamine – principalmente nella midollare del surrene – che, a loro volta, favoriscono un ulteriore incremento della secrezione di cortisolo. Inoltre, il rilascio di ossitocina risulta associato alla sensazione di benessere e alla coesione sociale, mentre una riduzione del cortisolo, osservata negli stati di gioia prolungata, suggerisce una minore reattività allo stress e un effetto protettivo sul sistema nervoso.
Le ricerche neuroscientifiche suggeriscono che una regolazione ottimale della gioia contribuisca alla resilienza emotiva, mentre un’alterazione nei circuiti che la governano può essere implicata in disturbi dell’umore, come la depressione anedonica, il disturbo bipolare o il disturbo ciclotimico. In particolare, durante gli episodi maniacali del disturbo bipolare si osserva un’intensa euforia, spesso accompagnata da iperattività, impulsività e ridotta necessità di sonno, mentre nel disturbo ciclotimico si alternano periodi di ipomania e sintomi depressivi di minore intensità.
Introduzione alla mimica facciale

La configurazione dello sguardo in questa emozione si distingue per un’ampiezza palpebrale che, pur non raggiungendo l’apertura massima osservabile nella sorpresa, risulta generalmente maggiore rispetto a quella presente in stati emotivi neutri o rilassati. L’attivazione del muscolo elevatore della palpebra superiore (levator palpebrae superioris) determina un sollevamento moderato della palpebra superiore, con un’intensità proporzionale alla carica emotiva: nelle forme più intense di gioia, fino all’euforia, si osserva un incremento della sua attivazione, che contribuisce a un’espressione di apertura e disponibilità. Parallelamente, l’azione del muscolo orbicolare dell’occhio (orbicularis oculi, pars palpebralis) genera un leggero innalzamento della parte inferiore della palpebra, tale da favorire una riduzione della fessura palpebrale nella sua porzione inferiore e contribuire alla tipica luminosità dello sguardo gioioso. Inoltre, la minore attivazione di alcuni muscoli perioculari e la riduzione della rigidità del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii) favoriscono una maggiore apertura all’area orbitaria, amplificando la percezione di spontaneità e trasparenza espressiva, e vitalità. L’interazione tra questi muscoli conferisce all’occhio un aspetto più disteso, armonioso e coinvolgente, in contrasto con la tensione muscolare associata alla rabbia o con la contrazione tipica della tristezza.
Dal punto di vista dinamico, lo sguardo in questo stato emotivo si caratterizza per una maggiore vivacità e reattività agli stimoli ambientali positivi, tra cui quelli sociali. Gli occhi risultano generalmente focalizzati e la direzione dello sguardo tende a essere più diretta e prolungata rispetto a emozioni come il disgusto o la tristezza, in cui il contatto visivo è spesso ridotto o deviato lateralmente. Questo profilo è particolarmente evidente nelle interazioni sociali, in cui la gioia è associata frequentemente a un aumento della fissità visiva, a un incremento della frequenza del battito palpebrale e a un’eventuale dilatazione pupillare, fenomeno che si verifica soprattutto nelle sue forme più intense e nell’euforia. A livello di attivazione neurofisiologica, l’esperienza di gioia influenza direttamente il circuito della ricompensa e la risposta del sistema autonomo. L’aumento dell’attività parasimpatica favorisce il rilassamento della muscolatura facciale, inclusa quella perioculare, il quale può contribuire anche a una maggiore fluidità della dinamica dello sguardo. In condizioni di euforia, invece, una più marcata attivazione del sistema simpatico può tradursi in una dilatazione pupillare più accentuata e in una maggiore espansione della fessura palpebrale, con una conseguente intensificazione dell’effetto di brillantezza e coinvolgimento emozionale dello sguardo.
Questa emozione, dunque, si manifesta attraverso un profilo oculare che comunica vitalità, energia positiva, apertura, coinvolgimento e distensione emotiva, e nitidezza. Il contrasto con altre emozioni risulta evidente nella naturalezza della configurazione palpebrale e nella dinamicità del contatto visivo, elementi che rendono lo sguardo gioioso un indicatore immediato dello stato emotivo positivo dell’individuo. Le evidenze raccolte mediante tecniche di neuroimaging e analisi morfologica evidenziano, infatti, come la modulazione dell’espressione oculare partecipi attivamente alla comunicazione interpersonale, in quanto svolge una funzione determinante nel facilitare l’interpretazione sociale della gioia e nel contribuire al consolidamento di segnali di benessere.
Terzo superiore del viso

Nell’espressione della gioia, l’assetto della regione che comprende il terzo superiore del volto si distingue per una caratterizzazione rilassata e distesa dei muscoli sopraccigliari, con un’attivazione specifica che contribuisce alla percezione di apertura e luminosità dello sguardo.
- La regione mediale delle sopracciglia si può sollevare leggermente per effetto del muscolo frontale (frontalis, pars medialis), sebbene in modo meno marcato rispetto alla sorpresa. Questo movimento contribuisce a un profilo più aperto e recettivo, privo della tensione che caratterizza altre emozioni come la paura o la rabbia.
- L’arcata sopraccigliare appare, in generale, distesa e priva delle contrazioni tipiche della rabbia o del disgusto. L’assenza di un’attivazione significativa del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii) contribuisce a una superficie frontale più levigata, senza le rughe verticali osservabili in stati di tensione emotiva. Questo aspetto è in netto contrasto con la rabbia, dove la contrazione del muscolo corrugatore genera una chiusura visiva più marcata.
- La regione laterale delle sopracciglia può mantenere una posizione neutra o subire un lieve sollevamento per l’azione del muscolo frontale (frontalis, pars lateralis). Questa attivazione, meno pronunciata rispetto alla sorpresa, amplifica comunque la percezione di apertura e coinvolgimento positivo, senza la rigidità associata a stati di allerta.
- La regione frontale e glabellare: la prima risulta generalmente priva delle rughe verticali tipiche di emozioni come la rabbia e la tristezza, a conferma della minore attivazione del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii). Allo stesso modo, l’assenza di rughe orizzontali sopra il ponte del naso indica una ridotta attivazione del muscolo procero (procerus). Analogamente, anche la regione frontale appare rilassata, senza le linee di tensione orizzontali che caratterizzano mimiche di preoccupazione o sorpresa, poiché il muscolo frontale (frontalis) non è significativamente attivato. Questo set muscolare contribuisce a una manifestazione più armoniosa, che enfatizza il senso di serenità e benessere.
- La regione perioculare infero-laterale: l’attivazione del muscolo orbicolare dell’occhio (orbicularis oculi, pars palpebralis) favorisce una leggera chiusura della palpebra inferiore, che conferisce allo sguardo la tipica espressione di calore e luminosità. Questa attivazione, in sinergia con la pars orbitalis, contribuisce alla formazione delle sottili rughe perioculari laterali (note anche come “zampe di gallina”), particolarmente evidenti nelle forme di gioia più intense, dove il coinvolgimento del muscolo è maggiore. Tale assetto si inserisce nel quadro più ampio del sorriso di Duchenne, in cui l’attivazione sinergica del muscolo orbicolare dell’occhio (orbicularis oculi, pars palpebralis e pars orbitalis) e del muscolo zigomatico maggiore (zygomaticus major) enfatizza l’autenticità dell’emozione.
Nel complesso, la regione superiore del viso nella gioia si caratterizza per un equilibrio tra apertura e rilassatezza, con un assetto muscolare che favorisce una mimica distesa e coinvolgente. Il contrasto con le emozioni negative è evidente nella naturalezza della disposizione muscolare e nella fluidità dell’espressione, elementi che rendono questa configurazione immediatamente riconoscibile come segnale di benessere e positività. Inoltre, la morfologia delle sopracciglia in questo stato emotivo si distingue per una curvatura parabolica con concavità orientata verso il basso, in contrasto con la manifestazione tipica della tristezza, in cui la concavità è rivolta verso l’alto. In particolare, la conformazione sopraccigliare, rispetto alla tristezza, delinea una curvatura più armoniosa e meno marcata, descrivibile mediante una funzione convessa con andamento parabolico. Questo assetto contribuisce a conferire al volto un profilo più aperto e disteso, con un effetto che enfatizza il senso di serenità e accoglienza.
Terzo medio del viso
Nel contesto della mimica gioiosa, le modificazioni nella regione che comprende il terzo medio del viso svolgono un ruolo significativo nell’accentuare il carattere aperto e accogliente dell’emozione. L’attivazione sinergica di diversi muscoli determina un’alterazione della morfologia del volto, che enfatizza l’armonia dei lineamenti e contribuisce a rendere la manifestazione emotiva immediatamente riconoscibile. Gli elementi distintivi in questa regione comprendono tipicamente il sollevamento delle guance, la definizione della piega nasolabiale e la distensione generale della muscolatura nasale, tutti aspetti che concorrono alla creazione di un’espressione spontanea e autentica.
- La regione nasolabiale assume un ruolo rilevante nella trasmissione dell’emozione attraverso una serie di modificazioni muscolari che conferiscono al volto un aspetto più aperto e armonioso. La piega nasolabiale, la linea che si estende dai lati del naso fino agli angoli della bocca, risulta generalmente più definita ma non contratta, in contrasto con quanto osservabile in emozioni come il disgusto, dove la trazione muscolare ascendente della cute intorno al naso ne accentua la tensione. L’attivazione del muscolo zigomatico maggiore (zygomaticus major), il cui effetto si ripercuote anche sulla regione nasolabiale, tende a rendere la piega più visibile e delineata. Tuttavia, a differenza di manifestazioni forzate o di tensione muscolare, nella gioia autentica tale configurazione risulta più distesa e dinamica, in sintonia con il rilassamento generale dell’assetto facciale. Inoltre, si osserva anche un’azione del muscolo elevatore del labbro superiore (levator labii superioris) che, indirettamente, può contribuire alla modulazione della curvatura della piega nasolabiale senza conferirle un profilo rigido o marcato. Questa caratteristica distingue la gioia spontanea da altre espressioni in cui la regione nasolabiale è più contratta o irregolare, come avviene nel disgusto o in alcuni stati di tensione emotiva.
- La regione geniena (porzione media) e la regione zigomatica: uno dei segnali più caratteristici di questa emozione è il frequente sollevamento delle guance, che conferisce al volto un aspetto più luminoso e disteso. Tale movimento è dovuto principalmente all’attivazione del muscolo zigomatico maggiore (zygomaticus major), il quale, oltre a intervenire nella mimica orale, esercita una trazione ascendente sulla regione geniena, condizione che enfatizza l’effetto di pienezza e tonicità del terzo medio del volto. Parallelamente, il muscolo orbicolare dell’occhio (orbicularis oculi, pars orbitalis), seppur indirettamente, può contribuire al sollevamento della porzione superiore delle guance. La sua attivazione determina un lieve effetto tensivo sulla cute della regione zigomatica, spesso sufficiente ad amplificare l’impressione di una maggiore tonicità e vivacità espressiva.
Terzo inferiore del viso

A livello prototipico, anche il terzo inferiore del viso assume un assetto distintivo, caratterizzato da una distensione generale della muscolatura e da un’attivazione muscolare che enfatizza l’apertura espressiva. La bocca rappresenta l’elemento più riconoscibile di questa emozione, poiché la sua forma, il grado di apertura e il coinvolgimento dei muscoli circostanti determinano il profilo complessivo del sorriso. La loro attivazione sinergica conferisce al volto un aspetto più luminoso e armonioso, in netto contrasto con le configurazioni più tese o asimmetriche osservabili in emozioni come la rabbia o il disgusto. Il sorriso, nella sua forma autentica, si distingue per la fluidità del movimento e per l’assenza di contrazioni muscolari che potrebbero conferirgli un’espressione innaturale, forzata o mascherata. Generalmente, nei sorrisi più lievi, gli angoli della bocca si sollevano moderatamente, senza una marcata esposizione dei denti; d’altro canto, nei sorrisi più ampi invece l’apertura della bocca diventa più evidente, e l’azione combinata dei muscoli elevatori nella regione orale contribuisce a una maggiore esposizione dentale, che enfatizza il carattere espansivo dell’emozione.
- La regione commissurale: gli angoli della bocca frequentemente subiscono una trazione ascendente, grazie all’azione del muscolo zigomatico maggiore (zygomaticus major) e del muscolo elevatore dell’angolo della bocca (levator anguli oris). Questo sollevamento contribuisce a conferire al volto un profilo più aperto e luminoso, differenziandosi nettamente dalle configurazioni osservabili nella tristezza, dove gli angoli della bocca risultano abbassati, e nella rabbia, in cui possono rimanere più contratti o leggermente abbassati senza una chiara simmetria. Nei sorrisi più ampi, inoltre, l’attivazione del muscolo risorio (risorius) può determinare una lieve trazione laterale della regione commissurale, che aumenta la percezione di ampiezza del sorriso e conferisce maggiore espressività all’emozione.
- L’apertura della bocca (quando presente): in questa emozione varia in base all’intensità del sorriso e può essere modulata da diversi fattori. Nei sorrisi più contenuti, spesso la mandibola rimane in una posizione neutra o subisce un lieve abbassamento, mentre nelle manifestazioni più marcate, il distanziamento delle arcate dentarie è più evidente. Il movimento mandibolare è determinato dall’azione combinata dei muscoli depressori della mandibola (digastrico, miloioideo e genioioideo), che permettono l’abbassamento della mascella. Tuttavia, a differenza di emozioni come la sorpresa, in cui l’apertura della bocca è più marcata e repentina, nella gioia essa appare più progressiva e naturale, senza rigidità muscolare.
L’aspetto dinamico della bocca in questo stato emotivo è fondamentale per la percezione dell’autenticità dell’emozione. A differenza di configurazioni più statiche o contratte, il sorriso autentico si manifesta attraverso un movimento spontaneo, fluido e naturale nel tempo. Le labbra rimangono morbide, distese e prive di contrazioni rigide. Il passaggio da un sorriso contenuto a una sua forma più espansiva avviene in modo graduale e senza tensioni marcate, a conferma dell’armonia dell’assetto muscolare. Questa fluidità distingue la gioia da espressioni più forzate o stereotipate, in cui la contrazione muscolare eccessiva può alterare la naturalezza dell’emozione trasmessa.
Fonti e letture consigliate
- B. Fredrickson, Positivity: Top-Notch Research Reveals the 3-to-1 Ratio That Will Change Your Life (2009).
- D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow (2011).
- B. Ehrenreich, Smile or Die: How Positive Thinking Fooled America and the World (2009).
- E. Cabanas, I. Illouz, Happycracy: How the Science of Happiness Controls Our Lives (2019).
- S. Ahmed, The Promise of Happiness (2010).
- A. Russell Hochschild, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (1983).
- A. Schüll, Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas (2012).
- N. Volkow, G. Koob, A. T. McLellan, Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction (2016), in New England Journal of Medicine, 374(4), pp. 363-371.
- A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello (2003).
- C. Held, The Tyranny of Positive Thinking: A Cultural Analysis of Happiness (2020).
- D. Matsumoto, H. S. Hwang, Culture and Emotion: The Integration of Biological and Cultural Contributions (2012), in Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(1), pp. 91-118.
- J. Tsai, Ideal Affect: Cultural Causes and Behavioral Consequences (2007), in Perspectives on Psychological Science, 2(3), pp. 242-259.
- K. C. Berridge, T. E. Robinson, Parsing Reward (2003), in Trends in Neurosciences, 26(9), pp. 507-513.
- R. J. Davidson, The Emotional Life of Your Brain (2012).
- J. Panksepp, Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions (1998).
- S. W. Porges, The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation (2011).
- U. R. Schubert, The Influence of Positive Emotions on Autonomic Nervous System Activity (2011), in Biological Psychology, 86(3), pp. 310-319.
- C. Heinrichs, G. Domes, M. J. Neumann, Oxytocin, Stress, and Social Behavior (2009), in Frontiers in Neuroendocrinology, 30(4), pp. 548-557.
- H. T. Mayberg, Modulating Mood Circuits in Depression: Deep Brain Stimulation for Treatment-Resistant Depression (2005), in Neuron, 45(5), pp. 651-660.
- E. J. Nestler, The Neurobiology of Depression (2015), in American Journal of Psychiatry, 172(5), pp. 409-416.
- F. Goodwin, K. Jamison, Manic-Depressive Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression (2007).
- A. R. Damasio, H. Damasio, & Y. Christen (a cura di), Neurobiology of Human Values (2005).
- P. Ekman, W. V. Friesen, Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues (1975).
- P. Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life (2003).
- P. Ekman, W. V. Friesen, J. C. Hager, Facial Action Coding System (FACS): The Manual (2002).