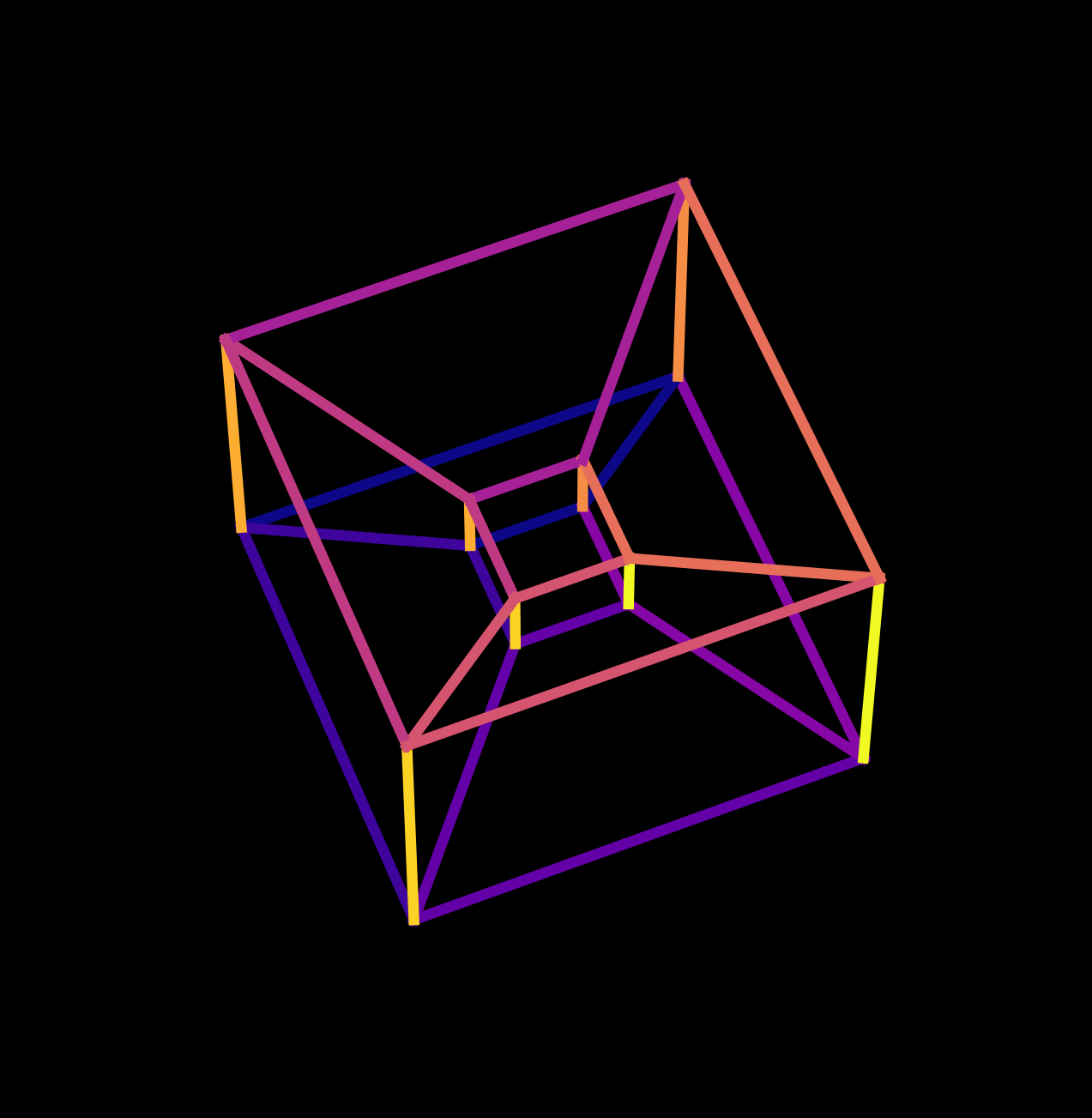Emotional Lens: Disgust – Article 6 of 6
Introduzione
Il disgusto è un’emozione primaria che si manifesta come una reazione spontanea di repulsione nei confronti di uno stimolo percepito come sgradevole, contaminante o pericoloso. Si tratta di un meccanismo adattivo che protegge l’individuo da potenziali minacce, evitando il contatto con sostanze nocive o situazioni avversive. Charles Darwin lo descrisse come una risposta immediata alla percezione di qualcosa di ripugnante, un riflesso istintivo volto a preservare l’integrità fisica e il benessere dell’organismo.
Questa emozione si attiva principalmente come reazione a stimoli sensoriali spiacevoli, come odori, sapori o immagini disgustose, ma può essere innescata anche da elementi di natura astratta, come pensieri, idee o comportamenti considerati offensivi, negativi, inaccettabili e immorali. In questo senso, essa non è solo un riflesso biologico strettamente legato alla sopravvivenza, ma si estende a una dimensione legata a norme sociali e convenzioni culturali, nonché a una dimensione morale, esprimendosi in risposta a comportamenti ritenuti moralmente riprovevoli; un segnale regolatore con componente retroattiva, modellato dalle memorie passate che hanno contribuito a plasmare il sistema di giudizi dell’individuo, che ne influenza anche la percezione nella valutazione di ciò che è accettabile o ripugnante e ne orienta le interazioni interpersonali e con l’ambiente. In particolare, la componente spesso definita come disgusto morale si manifesta come un senso di avversione nei confronti di atti percepiti come degradanti, scorretti o contrari a determinati principi etici influenzati da norme sociali e convenzioni culturali. Tuttavia, il disgusto morale non si basa sempre su principi etici “universalmente condivisi”, ma può essere influenzato da fattori soggettivi e personali, riflettendo schemi cognitivi individuali. A tal proposito, in una prospettiva più ampia e generale, questa variabilità legata alla soggettività individuale può estendere la reazione di disgusto oltre la dimensione morale. In particolare, in alcuni disturbi psicopatologici, come il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) e i disturbi alimentari, tale emozione può manifestarsi in modo atipico, emergendo in contesti che non rientrano nei suoi normali meccanismi adattivi.
Origine e funzione evolutiva
Sul piano evolutivo, secondo diverse teorie, il disgusto ha avuto un ruolo cruciale nella sopravvivenza degli esseri umani, favorendo la selezione di comportamenti di evitamento in risposta a stimoli potenzialmente dannosi per la salute. In particolare, esso avrebbe agito come un filtro percettivo e comportamentale per ridurre il rischio di esposizione a tossine, malattie e agenti patogeni. Per esempio, l’attivazione di una forte reazione di repulsione verso stimoli associati a odori di decomposizione, cibi avariati, fluidi corporei e ambienti insalubri, che induce l’individuo a evitare il contatto o l’ingestione di sostanze tossiche o potenzialmente nocive per l’organismo, evidenzia la funzione preventiva e protettiva di tale emozione per la salute. Inoltre, questo meccanismo essendo osservabile anche in altre specie animali, suggerisce che esso abbia una base filogeneticamente antica. Secondo la Pathogen Avoidance Theory, questa emozione si sarebbe evoluta come strategia di prevenzione delle infezioni, selezionando risposte di allontanamento da potenziali fonti di contaminazione. La reazione di disgusto è infatti particolarmente sensibile a stimoli legati alla trasmissione di agenti patogeni, come escrementi, sangue, insetti e corpi in decomposizione. Di conseguenza, in questa prospettiva, tale meccanismo adattivo di allerta riduce il rischio di contaminazione, contribuendo alla sopravvivenza della specie.
Inoltre, la mimica facciale caratteristica di tale stato emotivo è riconoscibile universalmente nelle diverse culture. In particolare, essa viene correttamente decodificata anche sul volto di individui non vedenti, così come in individui sordi sin dalla nascita, oltre a manifestarsi precocemente nei neonati, il che lascia ipotizzare l’esistenza di una rilevante base biologica innata del disgusto.
Basi neurobiologiche

Da un punto di vista neurobiologico, il disgusto è strettamente associato all’attivazione della corteccia insulare, una regione del cervello coinvolta nell’integrazione e nell’elaborazione di segnali sensoriali provenienti da diverse afferenze, tra cui quelle gustative, olfattive e interocettive. Studi di neuroimaging hanno dimostrato che l’insula si attiva in modo specifico quando un individuo è esposto a stimoli olfattivi e gustativi sgradevoli o osserva un’espressione facciale disgustata. Inoltre, evidenze neuroscientifiche indicano che tale regione può essere coinvolta anche in risposta a stimoli visivi non facciali e a situazioni associate a forme di disgusto sociale e morale, sebbene questi meccanismi siano più complessi e influenzati da altre strutture cerebrali.
Diversi studi suggeriscono un ruolo chiave della corteccia insulare nel riconoscimento e nell’elaborazione di questa emozione, sulla base di deficit neuropsicologici osservati in patologie che frequentemente la coinvolgono. In particolare, la Malattia di Huntington, un disturbo neurodegenerativo che colpisce primariamente i gangli della base e frequentemente coinvolge anche la corteccia insulare, è associata a un deficit selettivo nel riconoscimento e nell’espressione del disgusto, con un’eterogeneità clinica nella severità e nella specificità del deficit. Gli individui affetti da questa patologia tendono a presentare difficoltà marcate sia nel decodificare l’espressione facciale del disgusto altrui sia nel manifestarlo spontaneamente. Tuttavia, il riconoscimento e l’espressione delle altre emozioni di base sembrano rimanere relativamente preservati nelle fasi iniziali della malattia. A livello neurofunzionale, si riscontrano alterazioni che non configurano un deficit strutturale, ma una disfunzione dei circuiti neurali implicati nel disgusto. Nei disturbi ossessivo-compulsivi, si osserva frequentemente un’ipersensibilità al disgusto, che sarebbe associata ad alterazioni funzionali della corteccia insulare. Questa iperattivazione spiegherebbe l’intensa necessità di pulizia e igiene tipica di questi pazienti, che si riflette in rituali compulsivi di lavaggio e disinfezione, spesso caratterizzati da un’elevata ripetitività e resistenza alla modulazione cognitiva.
Introduzione alla mimica facciale

Per quanto concerne lo sguardo, in questa emozione si osserva generalmente una caratterizzazione in cui si ha una riduzione dell’ampiezza della fessura palpebrale, determinata dall’attivazione del muscolo orbicolare (orbicularis oculi) dell’occhio, che comprime leggermente la regione perioculare, e dalla ridotta azione del muscolo elevatore della palpebra superiore (levator palpebrae superioris), che lascia l’occhio in una posizione più chiusa, conferendo un aspetto più opprimente e pesante. Talvolta, si osserva anche una chiusura parziale delle palpebre, accompagnata da un irrigidimento del muscolo orbicolare, che accentua il senso di disapprovazione; come se l’individuo volesse limitare l’accesso visivo allo stimolo, attenuandone l’esposizione percettiva. Differenziandosi dalla rabbia, in cui lo sguardo risulta più penetrante e minaccioso, nel disgusto il restringimento oculare dona un aspetto meno aggressivo e più orientato all’allontanamento emotivo. Tuttavia, tale configurazione nel disgusto, in netto contrasto con l’apertura oculare tipica della sorpresa o della paura, trasmette anche una chiara espressione di avversione e repulsione. A livello della direzione dello sguardo, tale stato emotivo può essere accompagnato da una deviazione laterale, dovuta all’azione combinata del muscolo retto mediale (rectus medialis) e del muscolo retto laterale (rectus lateralis) dell’occhio. Questa tendenza può essere associata a una dinamica di evitamento dello stimolo, in cui l’individuo può volgere gli occhi di lato senza necessariamente ruotare il capo, suggerendo una reazione di distacco o di rifiuto nei confronti di ciò che suscita disgusto. In alternativa, si può osservare anche una lieve inclinazione verso il basso dello sguardo, correlata all’attivazione del muscolo retto inferiore (rectus inferior) e alla ridotta azione del muscolo retto superiore (rectus superior), come se volesse “chiudere lo sguardo” su di esso per limitarne l’esposizione. Infine, la frequenza del battito palpebrale può risultare ridotta per un breve istante, dando luogo a uno sguardo più statico o rigido. In alcuni casi, si osserva una fissità visiva temporanea, in cui l’individuo fissa lo stimolo prima di distogliere rapidamente lo sguardo, come parte della dinamica di respingimento ed evitamento.
Terzo superiore del viso
Nel disgusto, le sopracciglia tendono ad assumere una configurazione peculiare, spesso meno marcata rispetto alla rabbia, ma con elementi distintivi che ne riflettono la natura di avversione e ripulsa.
- La regione mediale delle sopracciglia tende ad abbassarsi leggermente, spesso grazie all’attivazione del muscolo procero (procerus). Sebbene questa contrazione non sia così intensa come nella rabbia, dove l’abbassamento è più netto e accentuato.
- L’arcata sopraccigliare può convergere leggermente verso l’asse longitudinale del viso, effetto dovuto all’attivazione del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii). Tuttavia, la contrazione è solitamente meno vigorosa rispetto alla rabbia, dove la tensione della fronte è più pronunciata.
- La regione laterale delle sopracciglia può mantenere una posizione relativamente neutra o abbassarsi leggermente, influenzata dall’attivazione combinata del muscolo orbicolare dell’occhio (orbicularis oculi, parte laterale) e del muscolo depressore del sopracciglio (depressor supercilii). Il primo contrae la regione perioculare, determinando una lieve chiusura della palpebra e esercitando una lieve trazione passiva verso il basso sulla porzione laterale dell’arcata sopraccigliare, con una possibile influenza sull’intera arcata, amplificando l’impressione di uno sguardo più distante; il secondo contribuisce direttamente all’abbassamento laterale delle sopracciglia, modulandone l’intensità. Tuttavia, tale segnale distintivo, se presente, risulta generalmente più lieve rispetto a quello osservabile nella tristezza; enfatizza una dimensione di distacco e rifiuto tipica di questa emozione, piuttosto che una di vulnerabilità emotiva.
- La regione frontale e glabellare: in questa emozione possano comparire leggere rughe verticali nella regione glabellare dovute all’attivazione del muscolo corrugatore del sopracciglio (corrugator supercilii). Inoltre, l’attivazione del muscolo procero (procerus) può contribuire alla formazione di sottili rughe orizzontali nella stessa area. Tuttavia, questo pattern di tensione nella glabella enfatizza l’espressione di repulsione e lo distingue da altre emozioni come la rabbia, in cui l’attivazione di questi muscoli è più marcata. Inoltre, a differenza della sorpresa, la fronte nel disgusto appare meno distesa e priva delle tipiche rughe orizzontali, che derivano principalmente dall’attivazione del muscolo frontale (frontalis) e accompagnano l’innalzamento delle sopracciglia. Infine, si osserva generalmente che un forte disgusto, rispetto a una rabbia lieve, può presentare più rughe orizzontali e meno rughe verticali sopra il ponte del naso.
Questo assetto della regione superiore del viso, pur avvicinandosi ad alcune caratteristiche della rabbia, si distingue per una minore intensità nella tensione frontale, un coinvolgimento maggiore del muscolo orbicolare dell’occhio e una minore attivazione dei muscoli coinvolti nella regione sopraccigliare, elementi che, nel complesso, lo rendono un’emozione più orientata all’allontanamento piuttosto che al confronto diretto o una manifestazione direttamente associata all’aggressività.
Terzo medio del viso

In questo stato emotivo, le modificazioni nel terzo medio del viso assumono un ruolo centrale nell’espressione di avversione e rifiuto. L’attivazione di specifici muscoli della regione nasale e periorale genera segnali distintivi che enfatizzano la percezione di qualcosa di sgradevole. Tra questi, il movimento del naso e la tensione nasolabiale e la dilatazione delle narici contribuiscono a rendere questa emozione immediatamente identificabile.
- La regione nasale: una delle caratteristiche più distintive, che frequentemente si osservano, è il movimento della parte centrale del naso, sopra le narici, che appare leggermente sollevata o contratta. Tale effetto, comunemente noto nell’immaginario collettivo come “naso arricciato”, è dovuto principalmente all’attivazione del muscolo procero (procerus), che contraendosi determina una trazione verso l’alto della cute della radice del naso, generando piccole rughe orizzontali sul ponte del naso che contribuiscono a trasmettere una chiara espressione di repulsione. In particolare, esse risultano più marcate nelle espressioni intense di disgusto e, sebbene possano assomigliare alle rughe visibili nella rabbia, si differenziano da quest’ultime per una minore profondità e per una maggiore distribuzione orizzontale.
- La regione nasolabiale: la cute intorno al naso e alla bocca assume spesso una maggiore tensione e può essere sottoposta a una trazione muscolare ascendente, determinando un’accentuazione della piega nasolabiale, ovvero la linea che si estende dai lati del naso fino agli angoli della bocca. Questo effetto deriva dall’azione combinata del muscolo elevatore del labbro superiore (levator labii superioris) e del muscolo dell’ala del naso (levator labii superioris alaeque nasi), i quali determinano un sollevamento simultaneo della parte superiore del labbro e della base del naso, incluse le ali nasali, con una leggera divaricazione di queste ultime. Inoltre, in alcune espressioni più marcate, si può osservare anche la comparsa di ulteriori piccole rughe verticali o diagonali adiacenti alle narici, che intensificano l’espressione di repulsione. Nell’insieme, queste modificazioni conferiscono alla parte mediana del viso un aspetto più contratto e definito, che contribuisce a enfatizzare l’intensità espressiva di tale emozione e a renderla particolarmente riconoscibile.
- Le narici: un ulteriore segnale distintivo, generalmente presente, è la trazione laterale delle ali nasali, che determina un ampliamento della base del naso e una lieve compressione del dorso. Questo movimento, dovuto all’attivazione del muscolo nasale (nasalis, in particolare la sua parte trasversa), intensifica l’espressione di disgusto, simulando un riflesso di evitamento olfattivo, come se l’individuo volesse ridurre l’esposizione a un odore sgradevole.
Terzo inferiore del viso

La configurazione della bocca è un elemento distintivo nell’espressione del disgusto e svolge un ruolo significativo nella trasmissione dell’emozione, distinguendolo da altre come rabbia o fastidio. La disposizione delle labbra e la tensione muscolare coinvolta delineano un’espressione caratterizzata da una chiusura marcata o, in alcuni casi, da una configurazione asimmetrica, spesso accompagnata da movimenti che enfatizzano il senso di repulsione. Quest’ultima, se presente, è generalmente più lieve rispetto a quella osservabile nel disprezzo, che si manifesta più marcatamente nella regione delle commissure labiali.
- Le labbra: in molte espressioni di questa emozione, la bocca appare chiusa o semiaperta, con una tensione evidente a livello labiale. L’attivazione del muscolo orbicolare della bocca (orbicularis oris) gioca un ruolo centrale nel mantenere una configurazione serrata o contratta, accentuando la sensazione di rifiuto nei confronti dello stimolo avversivo. Nei casi in cui essa si manifesta con una chiusura labiale intensa, il muscolo mentale (mentalis) contribuisce a elevare la parte centrale del labbro inferiore, incrementando la tensione nella regione del mento. Questo effetto può determinare una leggera proiezione in avanti del labbro inferiore, enfatizzando il senso di disapprovazione o distacco.
- La regione commissurale: un’altra configurazione ricorrente è la retrazione laterale delle labbra, che conferisce alla bocca una forma più ampia e contratta. Questo movimento è mediato dall’attivazione del muscolo risorio (risorius) e, in alcuni casi, del muscolo depressore dell’angolo della bocca (depressor anguli oris), i quali determinano una trazione degli angoli della bocca all’indietro e leggermente verso il basso. A differenza della paura, in cui la retrazione laterale delle labbra è spesso più tesa e associata a una preparazione all’azione, in questo stato emotivo essa assume una configurazione più statica, traducendosi in una smorfia di repulsione o in un’espressione di disapprovazione moderata.
- Scopertura dentale e contrazione asimmetrica: in alcune espressioni più marcate di disgusto, è possibile osservare una parziale scopertura dei denti, determinata da una lieve retrazione del labbro superiore. Questo effetto è principalmente dovuto all’attivazione del muscolo elevatore del labbro superiore (levator labii superioris), che contraendosi determina un’elevazione e una leggera proiezione anteriore della parte centrale del labbro, conferendo alla bocca un aspetto più contratto e meno rilassato. Tale configurazione si distingue dalla rabbia, in cui la scopertura dentale risulta spesso più ampia e accompagnata da una maggiore tensione muscolare. Nel disgusto, il movimento tende a essere meno pronunciato e più localizzato nella porzione centrale del labbro superiore, enfatizzando l’impressione di disprezzo o avversione. Tuttavia, in alcune espressioni, la contrazione muscolare non si manifesta in modo simmetrico, ma risulta più accentuata su un lato della bocca, con un’elevazione più marcata di un angolo del labbro superiore rispetto all’altro. Questa asimmetria è tipica delle espressioni meno marcate o più sottili di questa emozione, in cui la mimica facciale non è completamente attivata ma suggerisce comunque una reazione di rifiuto. In questi casi, il punto di maggiore trazione muscolare può spostarsi lateralmente, creando una configurazione che appare meno bilanciata rispetto alle espressioni più intense e simmetriche di disgusto.
- Apertura della bocca (quando presente): nelle espressioni di disgusto più intense, la bocca può aprirsi parzialmente, creando una configurazione meno contratta e più espressiva. Questo movimento è regolato dall’azione combinata dei muscoli depressori della mandibola, tra cui il muscolo digastrico (digastricus), il muscolo miloioideo (mylohyoideus) e il muscolo genioioideo (geniohyoideus), che determinano l’abbassamento della mandibola. A differenza della sorpresa, in cui l’apertura della bocca è più ampia e priva di tensioni marcate, in questo stato emotivo essa risulta generalmente più contenuta e spesso accompagnata da una retrazione delle labbra o da una tensione evidente nella regione periorale.
Fonti e letture consigliate
- C. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali (1872).
- M. Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge (2004).
- J. Haidt, “The Moral Emotions” (2003), in Handbook of Affective Sciences, R.J. Davidson, K.R. Scherer, H.H. Goldsmith (a cura di), Oxford University Press, pp. 852-870.
- R. Herz, That’s Disgusting: Unraveling the Mysteries of Repulsion (2012).
- W. I. Miller, The Anatomy of Disgust (1997).
- P. Rozin, J. Haidt, C. R. McCauley, “Disgust: The Body and Soul Emotion” (2000), in Handbook of Emotions, M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. F. Barrett, Guilford Press, pp. 637-653.
- V. Curtis, Don’t Look, Don’t Touch: The Science Behind Revulsion (2013).
- M. Schaller, J. H. Park, The Behavioral Immune System (and Why It Matters) (2011), in Current Directions in Psychological Science, 20(2), pp. 99-103.
- J. Haidt, C. McCauley, P. Rozin, “Individual Differences in Sensitivity to Disgust: A Scale Sampling Seven Domains of Disgust Elicitors” (1994), in Personality and Individual Differences, 16(5), pp. 701-713.
- A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello (2003).
- A. D. Craig, How do you feel—now? The anterior insula and human awareness (2009), in Nature Reviews Neuroscience, 10(1), pp. 59-70.
- A. J. Calder, J. Keane, F. Manes, N. Antoun, A. W. Young, Impaired recognition and experience of disgust following brain injury (2000), in Nature Neuroscience, 3(11), pp. 1077-1078.
- R. Sprengelmeyer, A. W. Young, A. J. Calder, A. Karnat, H. Lange, V. Hömberg, … H. Przuntek, Loss of disgust perception in Huntington’s disease (1996), in Brain, 119(5), pp. 1647-1665.
- D. J. Stein, C. Lochner, Disgust and obsessive-compulsive disorder (2006), in Disgust and Its Disorders: Theory, Assessment, and Treatment Implications, American Psychological Association, pp. 321-337.
- M. L. Phillips, A. W. Young, C. Senior, M. Brammer, C. Andrew, A. J. Calder, … A. S. David, A specific neural substrate for perceiving facial expressions of disgust (1997), in Nature, 389(6650), pp. 495-498.
- B. J. Harrison, J. Pujol, N. Cardoner, J. Deus, P. Alonso, M. López-Solà, … C. Soriano-Mas, Brain corticostriatal systems and the major clinical symptom dimensions of obsessive-compulsive disorder (2013), in Biological Psychiatry, 73(4), pp. 321-328.
- M. P. Paulus, M. B. Stein, An insular view of anxiety (2006), in Biological Psychiatry, 60(4), pp. 383-387.
- B. Wicker, C. Keysers, J. Plailly, J. P. Royet, V. Gallese, G. Rizzolatti, Both of us disgusted in My insula: the common neural basis of seeing and feeling disgust (2003), in Neuron, 40(3), pp. 655-664.
- H. D. Critchley, S. Wiens, P. Rotshtein, A. Öhman, R. J. Dolan, Neural systems supporting interoceptive awareness (2004), in Nature Neuroscience, 7(2), pp. 189-195.
- D. Mataix-Cols, S. K. An, N. S. Lawrence, X. Caseras, A. Speckens, V. Giampietro, … M. L. Phillips, Individual differences in disgust sensitivity modulate neural responses to aversive/disgusting stimuli (2008), in European Journal of Neuroscience, 27(11), pp. 3050-3058.
- J. M. Gray, A. W. Young, W. A. Barker, A. Curtis, D. Gibson, J. S. Snowden, Impaired recognition of disgust in Huntington’s disease gene carriers (1997), in Brain, 120(11), pp. 2029-2038.
- R. Ille, Andreas Schäfer, Anne Schienle, G. Weniger, C. R. Blecker, J. Peissig, Emotion recognition and experience in Huntington’s disease: Is there a differential impairment? (2007), in Psychiatry Research, 157(1-3), pp. 67-78.
- I. J. Mitchell, H. C. Heims, E. A. Neville, H. E. Rickards, Impaired recognition of disgust in Huntington’s disease: A longitudinal study (2005), in Neuropsychologia, 43(4), pp. 572-580.
- P. Ekman, W. V. Friesen, Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues (1975).
- P. Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life (2003).
- P. Ekman, W. V. Friesen, J. C. Hager, Facial Action Coding System (FACS): The Manual (2002).