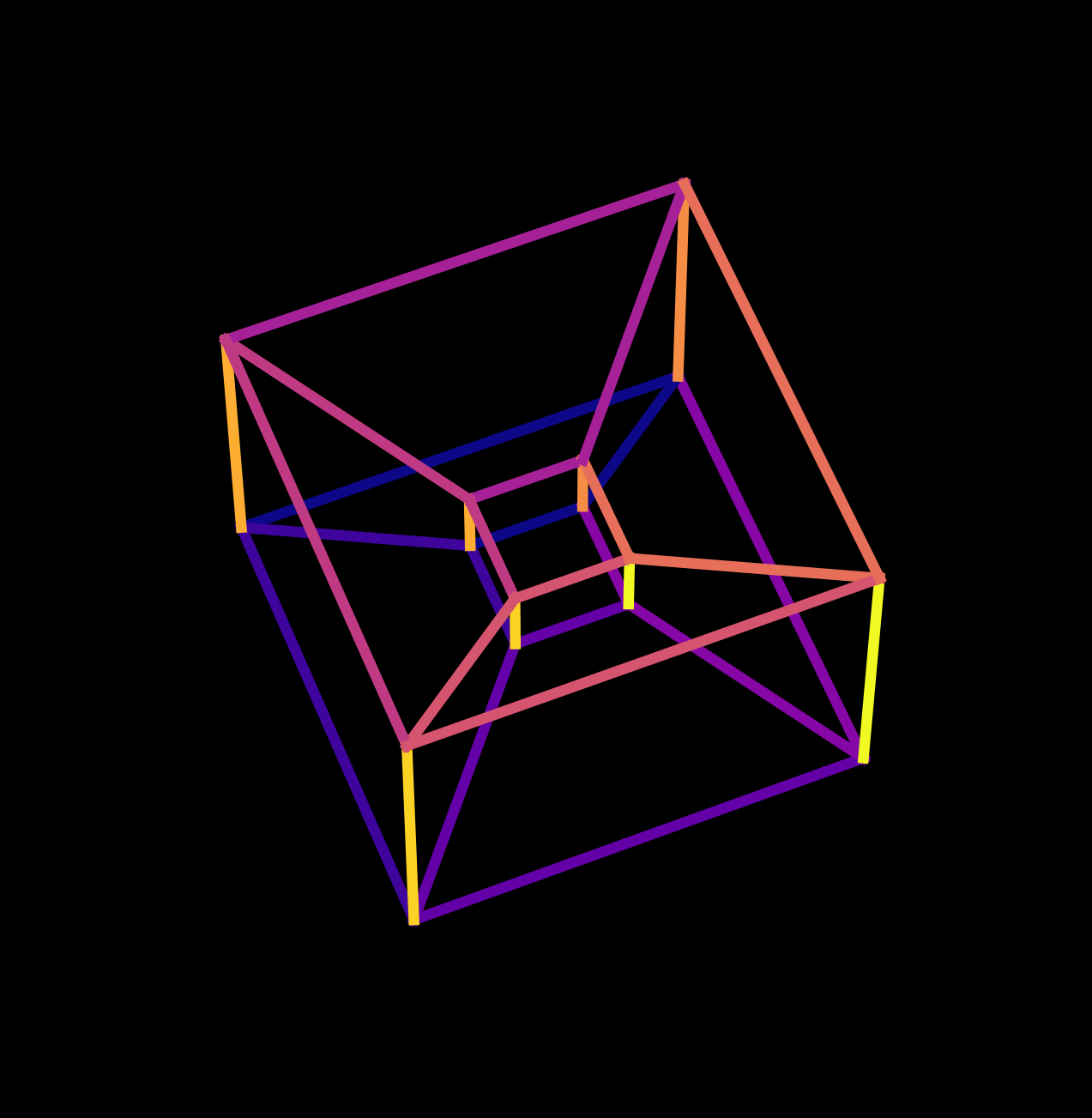- Chi è lo psicologo?
- Introduzione
- Codice Deontologico (introduzione)
- Profili professionali e settori di intervento
- Orizzonte occupazionale ed esercizio della professione di psicologo in regime di consulenza, in regime di rapporto di lavoro dipendente e in regime di lavoro autonomo
- Strumenti e attività caratterizzanti la professione di psicologo
- Riservatezza sui dati relativi all’utente
- Normativa sulla privacy
- Approfondimento sulla prestazione psicologica (Codice Deontologico)
- Fonti e letture consigliate

Chi è lo psicologo?
Introduzione
Lo psicologo non è un medico, bensì un professionista della salute laureato in Psicologia, abilitato all’esercizio della professione tramite Esame di Stato e successivamente iscritto all’Ordine professionale degli psicologi (l’elenco degli iscritti è pubblico e accessibile via internet), che funge da garante per il corretto comportamento tecnico e deontologico del singolo Iscritto all’Albo, in accordo con l’Ordinamento della professione di psicologo sancito dalla Legge 18/02/1989, n°56. Dunque, senza l’iscrizione all’Albo non si è psicologi ma solo laureati in Psicologia. Inoltre possono sostenere tale esame coloro che solo laureati in Psicologia e hanno obbligatoriamente svolto un tirocinio formativo, nel quale si fa esperienza nel campo della Psicologia con la supervisione di un tutor-professionista iscritto all’Albo che vigila sulla formazione del neolaureato, lo accompagna e lo sostiene. Tuttavia, anche durante il corso di laurea sono previsti periodi di collaborazione con strutture pubbliche o private: si tratta delle cosiddette “Attività Formative Pratiche” (A.F.P.).
In particolare, per quanto concerne la formazione di base minima per accedere all’Albo è stabilita per legge, ed è attualmente di due tipi, infatti l’Albo è suddiviso in due sezioni. Ovverosia come da D.M.509/99 e derivanti, che hanno dato luogo, a partire dall’anno accademico 2001/2002, ad una riforma generale di tutti gli ordinamenti dei corsi di studio nelle Università italiane, si accede alla sezione B dell’Albo con la qualifica di “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” previo Esame di Stato con il titolo di laurea triennale o di I° livello nella “Classe universitaria 34” e sei mesi di tirocinio, pertanto tale figura professionale possiede conoscenze e competenze ridotte rispetto a quella dello psicologo. In particolare, tra le quali la realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare progressi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita; l’applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane e di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività; l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni, nonché l’elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo e, dove richiesto, la collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; ulteriormente, si avvale della collaborazione dello psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione, ad esempio tra i membri della famiglia, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità, ma anche negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica del comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale.

Mentre si accede alla sezione A dell’Albo previo Esame di Stato con il titolo di laurea specialistica, da non confondere con la specializzazione, o di II°livello nella “Classe universitaria 58/S” (3+2), ovvero la laurea secondo l’Ordinamento previgente [Vecchio Ordinamento], ovvero la laurea Magistrale [ DPR 270/04 ] e un tirocinio della durata di un anno. Indi per cui, quest’ultima sezione è formata da coloro che hanno il titolo di psicologo le cui funzioni sono quelle descritte dall’Art.1 L.56/89 a cui si aggiungono il coordinamento e la supervisione dell’attività dei dottori in scienze e tecniche psicologiche come da DPR 328/2001. L’insieme degli psicologi iscritti allAlbo forma l’Ordine degli Psicologi che è organizzato a livello regionale, tranne le province di Trento e Bolzano che sono strutturati a livello provinciale. Infine i presidenti di tutti i Consigli regionali costituiscono il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOP). L’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale degli Psicologi aspetta al Ministero della Salute (art. 24 sexies, comma 2, Legge 31/2008), che riconosce la Psicologia come professione della salute.
Codice Deontologico (introduzione)
L’Ordine degli Psicologi è pertanto teso a difendere gli interessi dell’utenza ed a garantire la qualità del lavoro del professionista, anche attraverso il suo Codice Deontologico, elaborato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ed entrato in vigore il 16/02/1998, che si ispira a seguire i seguenti “principi fondamentali”:
- Rispetto dei diritti fondamentali della persona, della sua autonomia e della sua dignità, come sancito dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
- Responsabilità individuale, professionale e sociale dello psicologo.
- Integrità, onestà, probità a livello individuale e professionale.
- Autonomia ed identità professionale.
- Competenze, intesa sia come conoscenze delle tecniche e degli strumenti di intervento sia come “consapevolezza” delle proprie capacità e dei propri limiti.
- Promozione attiva del benessere individuale e sociale, a tutela complessiva dell’utente, del committente, del gruppo professionale e del singolo professionista.
Profili professionali e settori di intervento
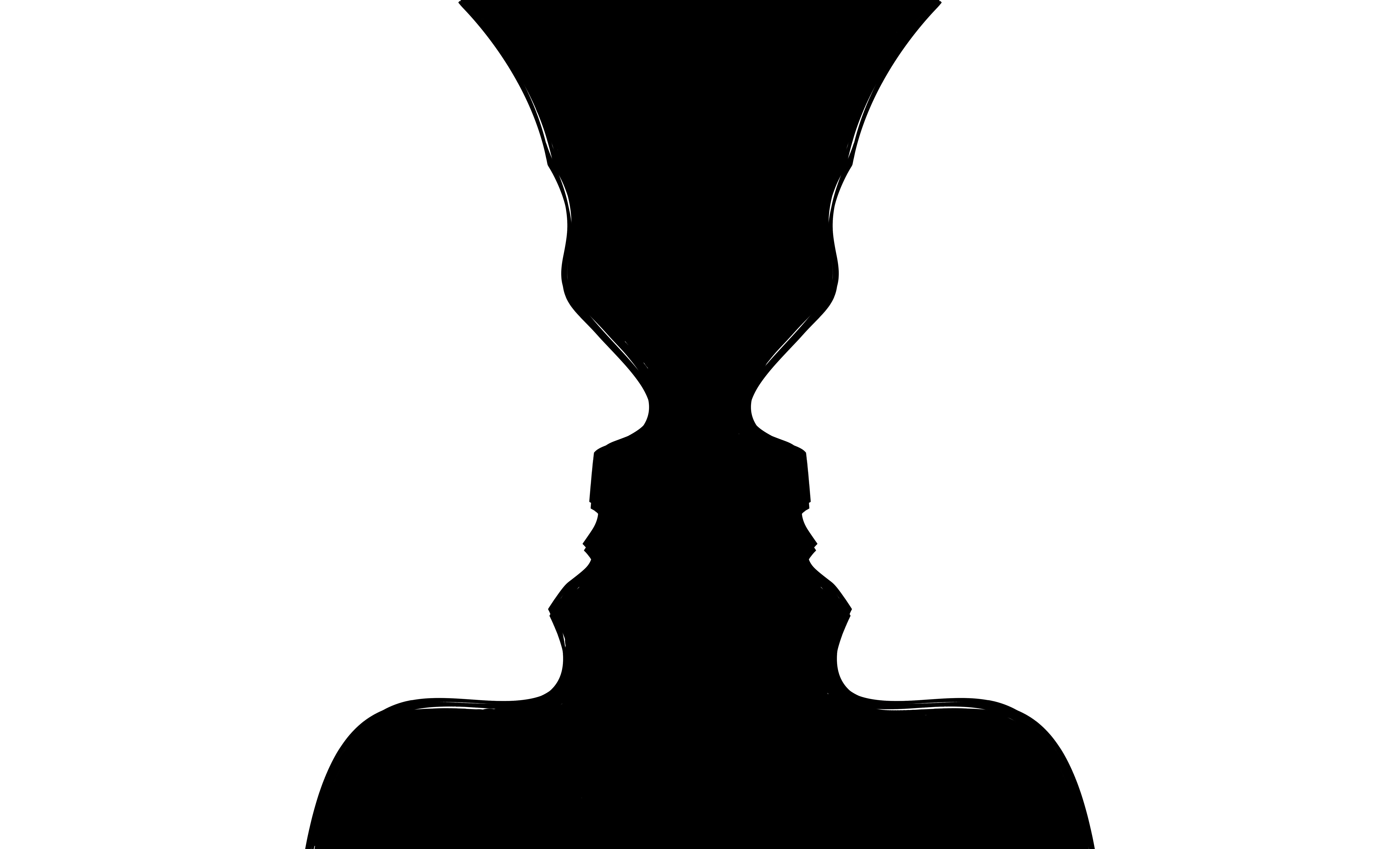
Lo psicologo può specializzarsi in settori e ambiti differenti della Psicologia e quindi acquisire competenze diverse già durante il percorso universitario in quanto esistono all’interno delle università indirizzi formati diversi, alcuni di consolidata tradizione ed altri emergenti, tra i quali citiamo:
- Psicologia clinica e della salute: comprende aree importanti quali la Psicologia ospedaliera, la Psicodiagnostica, la Neuropsicologia clinica, la Psicologia delle disabilità e della riabilitazione, la Psicologia delle dipendenze patologiche e soprattutto la Psicoterapia (l’attività esercitata solamente dallo psicoterapeuta). Lo psicologo clinico si occupa perciò dello studio scientifico e applicativo delle problematiche psicologiche e relazionali dell’individuo, della famiglia e del gruppo. (Per approfondimenti: Strumenti e attività caratterizzanti la professione di psicologo). A tal riguardo, contestualmente, gli psicologi sono specializzati nell’individuazione di fattori biologici, psicologi e sociali che possono influenzare la salute mentale e sensibilizzano, peraltro, tecnici sanitari ai problemi psicologici derivanti dal dolore, dallo stress ecc..
- Psicologia sperimentale: comprende l’ambito della ricerca di base applicata, le Neuroscienze, la Neuro-Psicobiologia, la Psicometria e gli studi sulla struttura e le funzioni della personalità. Essenzialmente, quindi, il professionista svolge attività di studio e di ricerca nel campo della Psicologia sperimentale e delle sue connessioni con le scienze umane, biologiche, cliniche, artificiali e delle Neuroscienze cognitive, ovverosia, inoltre, si occupa di analizzare il funzionamento della mente, in situazioni di normalità e di patologia, in relazione al suo substrato biologico. In particolare, il neuropsicologo studia la relazione esistente tra i sistemi cerebrali e il comportamento manifesto attraverso la messa in atto di tecniche di neuroimaging, come la PET (tomografia ad emissione di positroni), la fMRI (risonanza magnetica funzionale) e studi di psicofisica comportamentale; ulteriormente egli valuta e riabilita attraverso l’applicazione di test neurocognitivi il funzionamento cognitivo non solo in caso di lesione cerebrale ma anche in pazienti con malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson ecc.) e in caso di “invecchiamento precoce”. A tal proposito, invece, gli psicologi cognitivi studiano le funzioni cognitive superiori dell’essere umano come la percezione, il pensiero, l’attenzione e la memoria; ulteriormente, essi sono interessati a capire come la mente rappresenta la realtà, le modalità di apprendimento di una serie di nozioni e come il linguaggio è compreso e riprodotto. Infine gli psicologi cognitivi collaborano con i neuroscenziati per capire cosa avviene a livello cognitivo e quali sono le basi biologiche del disagio mentale. Tuttavia, dal punto di vista storico e concettuale, la nascita e lo sviluppo della Psicologia sperimentale è legato alla Psicometria, ossia agli psicologi esperti in statistica, gli psicometristi, che si occupano della definizione e dell’utilizzo dei metodi e delle tecniche d’indagine psicologica inerenti alla progettazione di esperimenti e l’analisi dei dati; in particolare, alcuni di essi sviluppano e valutano modelli matematici promuovendo nuovi metodi volti a migliorare i test psicologici, nuove procedure statistiche, altri creano strategie di ricerca per valutare l’effetto di programmi sociali, educativi e psicologici. Infine, per quanto concerne l’ambiente in cui può essere effettuata l’osservazione e quindi in relazione all’osservazione (palese, dissimulata, strutturata, non strutturata, partecipata, semi-partecipata) come strumento conoscitivo nella ricerca, alcune si svolgono in laboratorio, ove le condizioni di studio possono essere controllate con attenzione (osservazione in condizioni di controllo), altre invece sono effettuate sul campo (osservazione condotta sul campo), per verificare direttamente come si manifesta una dato comportamento.

- Psicologia dello sviluppo e dell’educazione: in questa macro-arca sono compresi settori importanti quali la Psicologia dello sviluppo, la Psicologia dell’adolescenza, la Psicologia dell’educazione, la Psicologia scolastica, la Psicologia dell’apprendimento, la Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale. La Psicobiologia, definita come una braca delle Neuroscienze, studia il comportamento umano, i processi mentali in stretta connessione con gli aspetti biologici. In tale contesto, gli psicologi dello sviluppo studiano lo sviluppo psicologico dell’essere umano durante tutto l’arco della vita, inoltre, essi ad esempio lavorano su bambini, adolescenti e anziani attraverso l’applicazione di tecniche d’intervento psicologico e psicodiagnostico che consentano di superare il disagio.
- Psicologia sociale applicata: comprende ad esempio la Psicologia della salute, la Psicologia di comunità, la Psicologia dell’anziano, la Psicologia della interculturalità ed altri ancora. Gli psicologi sociali si occupano, in breve, di studiare come la vita mentale di una persona e il comportamento siano modellati dalle interazioni con le altre persone, per cui sono interessati a tutti gli aspetti delle relazioni interpersonali, comprese sia le influenze individuali che del gruppo, migliorandone l’interazione. D’altro canto, essi facilitano la comprensione di atteggiamenti sociali dannosi, come nel caso del pregiudizio, facilitandone il cambiamento.
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: Essa comprende a sua volta la Psicologia delle risorse umane, la Psicologia del lavoro, la Psicologia delle organizzazioni, la Psicologia dell’orientamento professionale, la Psicologia della formazione professionale, la Psicologia del marketing e delle comunicazioni pubblicitarie, la Psicologia ergonomica. Lo specialista si concentra, in breve, sullo studio dei comportamenti degli individui all’interno dei contesti lavorativi, per migliorare la produttività, la salute dei lavoratori e la qualità della vita lavorativa, ponendo anche molta attenzione agli aspetti interpersonali. Dunque, in tale ottica, il professionista si focalizza ad esprimere una competenza psicologica clinico-organizzativa orientata all’attivazione di dinamiche relazionali al contempo efficaci e soddisfacenti, promuovendo la formazione e lo sviluppo, per l’individuo e i gruppi. Inoltre, essi svolgono attività di consulenza nella gestione di settori quali la pianificazione strategica in una azienda, la gestione delle risorse aziendali o fronteggiamento delle problematiche. A tal proposito, la figura dello psicologo del lavoro diventa estremamente importante nei casi di mobbing o di elevato stress-lavoro correlato che possono verificarsi in alcune situazioni. In questi casi è possibile sia svolgere un intervento sul lavoratore “vittima” sia attuare un intervento formativo nei contesti aziendali, coinvolgendo quindi tutto il gruppo di lavoro.
- Psicologia giuridica e forense: lo psicologo è un professionista che svolge sia attività con funzioni operative, per l’accoglienza, il sostegno e l’assistenza del minorenne coinvolto nel circuito penale e per l’elaborazione e la messa in opera di percorsi di aiuto alle famiglie in situazioni di difficoltà o conflitto connesse alla separazione, al divorzio o altri contesti giurisdizionali. Sia con funzioni organizzative, per la programmazione, la progettazione, la gestione e la verifica del servizio psicologico offerto dal territorio negli ambiti sopra menzionati sia valutative, svolgendo attività di CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) e CTP (Consulenza Tecnica di Parte), ovverosia consulenza e perizie per i Tribunali anche in relazione ad eventuali abusi e maltrattamenti, nell’iter giuridico per la rettificazione di attribuzione di sesso ecc. A tal proposito, nel contesto civile, lo psicologo con una formazione forense sarà in grado di operare a diversi livelli di intervento che prevedono: le valutazioni psicologiche delle competenze genitoriali, la valutazione dello stato di abbandono del minore, dell’idoneità all’adozione, nonché degli affidi minorili, la tutela dell’infanzia, la valutazione del danno psichico ed esistenziale, e la valutazione delle capacità di agire, anche nel contesto di procedimenti di amministrazione di sostegno e di interdizione.
- Psicologia dello sport: a favore di atleti che praticano attività individuali o di squadra e per le società sportive. Gli psicologi dello sport, possono ad esempio aiutare gli atleti a focalizzare le loro attenzioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, diventando di conseguenza più motivati e capaci di gestire l’ansia (l’ansia da prestazione) e la paura del fallimento che spesso accompagna l’attività agonistica.
Tuttavia, parallelamente alle hard skills, ossia le competenze conoscitive e metodologiche che dipendono dal bagaglio formativo e dalle esperienze lavorative pregresse, vi sono le soft skills, ossia tutte quelle abilità trasversali di tipo comportamentale e relazionale, nonché cognito ed emotivo, che non si contrappongono alle hard skills ma piuttosto si integrano nella definizione di un profilo professionale. Infatti, sebbene entrambe possono essere acquisite o rafforzate progressivamente attraverso appositi piani di formazione, le soft skills sono maggiormente e strettamente dipendenti dalle inclinazioni e dalle attitudini della persona. Sono un esempio alcuni aspetti in relazione all’intelligenza: linguistica, emotiva, interpersonale, intrapersonale; la flessibilità e l’adattabilità: la capacità di modificare efficacemente comportamenti e meccanismi mentali in funzione delle molteplici e mutevoli situazioni del contesto lavorativo, adattandosi anche alle emergenze, ai cambiamenti e alle esigenze di ogni persona o gruppo; il il pensiero analitico: la capacità di comprendere le situazioni, scomponendole nei loro elementi costitutivi, individuando relazioni e sequenze cronologiche e valutare le conseguenze in una catena di causa ed effetti; il problem solving, la creatività, l’insight et cetera.
Orizzonte occupazionale ed esercizio della professione di psicologo in regime di consulenza, in regime di rapporto di lavoro dipendente e in regime di lavoro autonomo
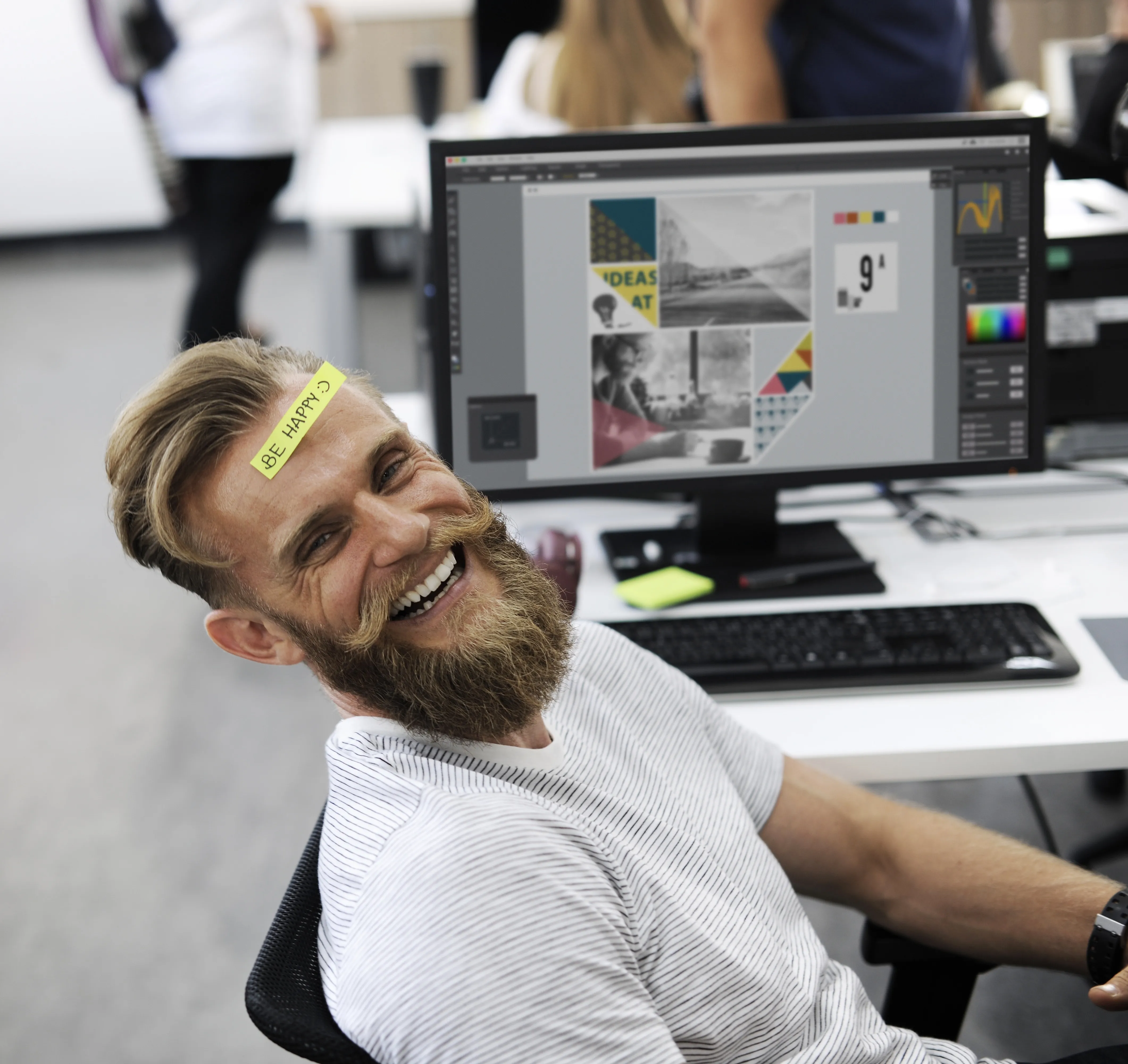
Lo psicologo può svolgere la propria attività in regime di dipendenza o di collaborazione sia presso strutture che operano nel settore privato e/o convenzionato (comunità terapeutiche, centri di riabilitazione, centri di ascolto, case famiglia, centri di aggregazione giovanile, centri di accoglienza, ospedali e cliniche private, studi professionali, studi legali, associazioni, fondazioni, ONG, enti di ricerca, aziende private, società di consulenza e formazione aziendale, scuole private ecc. ) sia nei Servizi Sanitari, nelle Istituzioni pubbliche (ASL, Servizi per le Tossicodipendenze –SerT– e Servizi per le Dipendenze patologiche –SerD– , cliniche e ospedali pubblici, consultori, servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, scuole pubbliche, enti di formazione, tribunali, centri per la giustizia ecc. ), capillarmente presenti sul territorio regionale e nazionale. Tuttavia in accordo con la L. 833/1978 nell’ambito di strutture come le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, attraverso cui le Regioni, in armonia con il dettato costituzionale, garantiscono l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei cittadini, può essere richiesta dalla natura dell’incarico un’ulteriore specializzazione quadriennale in Psicoterapia. Indi per cui lo psicologo può esercitare la propria professione in autonomia o in modo integrato con le altre figure professionali coinvolte nel servizio ( il medico di base, il pediatra, lo psichiatra, l’endocrinologo, il nutrizionista, ma anche con altri professionisti come il giudice, l’avvocato, l’insegnante, l’assistente sociale ecc. ). In particolare, può anche collaborare con eventuali equipe multidisciplinari per la la definizione e/o la realizzazione dell’intervento. Peraltro coloro che sono impegnati nelle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale o in strutture private convenzionate hanno per legge l’obbligo di una formazione continua specifica, attraverso il cosiddetto “programma E.C.M.” (Educazione Continua in Medicina) che si basa sui “crediti formativi” valutati dal Ministero della Salute. L’orientamento attuale è di estendere l’obbligo di tale formazione anche agli psicologi liberi professionisti, specie se abilitati alla psicoterapia. In ogni caso gli psicologi hanno da sempre una tradizione che porta a dedicare un congruo periodo di tempo alla propria formazione continua attraverso corsi, convegni, seminari e la supervisione di casi clinici. Tutto ciò sia per garantire a se stessi le capacità professionali richieste dalla rapida evoluzione che la Psicologia ha subito in questi anni, sia per garantire ai cittadini risposte e prestazioni corrette, competenti ed efficaci.
Infine, come accennato, lo psicologo può lavorare anche come libero professionista, gestendo autonomamente la propria attività all’interno di uno studio privato o associato ad altri professionisti. A tal proposito, per quanto riguarda la retribuzione, le tariffe possono variare a seconda del tipo di intervento, ma ogni professionista deve attenersi al tariffario proposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi e approvato dai Ministri della giustizia e della sanità. In particolare, ad esempio, gli onorari possono essere calcolati a percentuale sul valore dell’intervento, calcolato sulla base degli interessi su cui incide la prestazione, oppure a vocazione, ossia a tempo, pertanto sulla base della complessità, dell’urgenza, della situazione economica del cliente, sull’appartenenza a categorie con cui sono state stipulate convenzioni, sulla competenza specifica dello psicologo. Inoltre in caso di “manifesta sproporzione” fra prestazione e onorario, su parere dell’Ordine, il compenso può essere abbassato o maggiorato. Infine, se il cliente non si presenta all’appuntamento l’onorario può essere ridotto o non richiesto e in caso di interruzione dell’incarico lo psicologo ha diritto alle spese di preparazione dell’intervento. In ultima analisi, le Linee Guida per le Prestazioni Psicologiche via internet e a distanza suggeriscono che le attività di psicodiagnostica e psicoterapeutica svolte via internet sono da svolgere con estrema cautela. In particolare, lo psicologo deve essere chiaramente identificabile e deve segnalare all’Ordine il proprio sito e gli utilizzatori dei servizi vanno di norma identificati.
Strumenti e attività caratterizzanti la professione di psicologo

La professione dello psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento, che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica, per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte all’individuo, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità sia in età evolutiva, infanzia e adolescenza (nel caso di attività con minori o interdetti ottiene il consenso informato da genitori o tutori), che in età adulta. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica al fine di far progredire le conoscenze in tale ambito. Oggetto del suo interesse è il funzionamento della mente, intesa in senso ampio come psiche, con le sue componenti biologiche e fisiologiche, cognitive e mnesiche, attentive, emotive e affettive, nonché relazionali e ambientali.
Tale figura professionale in particolare è legittimata a compiere interventi che spaziano nel campo della salutogenesi, ossia la prevenzione del disagio, la promozione della salute psicologica e la modifica dei comportamenti a rischio. La prevenzione, intesa anche come atto valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle attività finalizzate a sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e condotte a rischio da perseguire. A tal fine altresì promuove processi di sviluppo mirati all’intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali, di carattere consapevole e non, che influenzano l’agire umano.
D’altro canto, tale qualifica gli permette di operare interventi psicologici anche di diagnosi, ovvero l’atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo, in risposta a una domanda, che si avvale di modelli teorici di riferimento dei processi mentali, del comportamento e della relazione. Al fine di poter definire un processo psicologico con funzione diagnostica ed orientativa, lo psicologo sia avvale degli strumenti osservativi, del colloquio psicologico (intervista strutturata, intervista semistrutturata, colloquio orientato, colloquio clinico) e del proprio strumento psicodiagnostico e neuropsicologico (strumenti di misurazione come test: carta-matita, proiettivi, questionari, Rating Scales e altri strumenti standardizzati), d’uso esclusivo per l’analisi, la comprensione e l’interpretazione del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni. Per quanto concerne i test di livello, sono un esempio le scale Wechsler (WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale) o le Matrici di Raven per l’intelligenza, il Bender Visual Motor Gestalt Test o la Scala Brunet-Lézine per la valutazione degli aspetti percettivo-motori, la Vineland Adaptive Behaviour Scale (V.A.B.S.) per la valutazione dell’autonomia personale e della maturità-responsabilità sociale. Peraltro, tra i test di sviluppo, citiamo le Prove Piagetiane per la valutazione degli aspetti cognitivi, fondantisi sul modello “stadiale” di sviluppo proposto da Piaget; La Strange-Situation per la valutazione dello sviluppo affettivo-relazionale sulla base della Teoria dell’attaccamento formulata da Bowlby. Ulteriormente, in relazione ai reattivi proiettivi inerenti la personalità vi sono le tecniche costitutive come il famoso Test di Rorschach e lo Zulliger Test (o Z-Diapositive-Test); le tecniche interpretative o test narrativi come il Test di Appercezione Tematica (T.A.T.) e la variante per bambini Children Apparcetion Test (C.A.T.) di Murray, il Separation Anxiety Test (S.A.T.) di Attili, le Blacky Pictures, la Tecnica delle Relazioni Oggettuali (O.R.T.); infine, le tecniche costruttive o espressive grafiche come il Test dell’Albero di Cock, il Disegno della Figura Umana, il Disegno della Famiglia, il Disegno della Persona sotto la Pioggia, il Disegno della Casa, i Disegni della Gioia e della Tristezza, il Test di Wartegg. Altresì, tra le tecniche obiettive comelescale psicopatologiche, Rating Scales, (monofasiche o multifasiche a seconda che indaghino uno specifico aspetto patologico della personalità o più aspetti congiuntamente) citiamo la Beck Depression Inventory per la valutazione della presenza di sintomi depressivi, o la State-Trait Anxiety Inventory (STAI) per la valutazione dell’ansia di stato e di tratto, la Stress Symptom Rating Scale per la valutazione quotidiana dello stress. D’altro canto tra i questionari di personalità (auto o etero-somministrati) più diffusi si ricordano il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), il Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Adolescent (MMPI-A), il Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI III), il Big Five Questionnaire (BFQ), il California Personality Inventory (CPI), il Millon Adolescent Personality Inventory (MAPI), la batteria Cognitive Behavioural Assessment (C.B.A-2.0). E altri test neuropsicologici come il Test di Corsi (per la valutazione della memoria), il Test dei Gettoni (per la valutazione del linguaggio), il Test della Figura Complessa di Rey (per la valutazione del coordinamento visuo-spaziale e degli aspetti di memoria, il Test delle Campanelle (per la valutazione degli aspetti attentivi). Inparticolare, dunque, il colloquio e i reattivi possono avere come oggetto di osservazione un individuo o un gruppo di persone. Strumento fondamentale, infine, è la personalità dello psicologo, che entra attivamente in relazione con l’oggetto della sua osservazione e della sua valutazione nella cosiddetta osservazione partecipata.
Conseguenza dell’azione diagnostica, in determinate circostanze, è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione, e che comprende tutte quelle attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo e nelle istituzioni. In particolare il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio (dinamico) fra la persona, con i suoi bisogni e le sue risorse, e le richieste dell’ambiente in cui vive. Esso rappresenta, dunque, una condizione dinamica, in continuo mutamento e riadattamento, il cui equilibrio non è dato a priori, ma costruito ogni volta anche in relazione al contesto socioculturale in cui si è inseriti. Per quanto concerne la riabilitazione psicologica, di tipo anche cognitivo-funzionale, lo psicologo si avvale, anche qui, di tecniche mutate da teorie, modelli, costrutti psicologici e comprende tutte quelle attività che prevedono un percorso di valutazione psicologica, di assessment e di consulenza finalizzate ad una reintegrazione e recupero, oppure una compensazione nei casi in cui non sia possibile il recupero, di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o una perdita. Rientrano in tale ambito l’attuazione di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, disturbi cognitivi e dell’apprendimento compresi nella definizione di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), di deficit neuropsicologici a seguito di malattie degenerative, disturbi psichiatrici o con dipendenze da sostanze.

Particolare importanza riveste, inoltre, il sostegno psicologico, la funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere che si realizza in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire continuità e contenimento ad una data condizione al soggetto del servizio. Il sostegno psicologico quindi può seguire, ad un intervento riabilitativo con il fine di rinforzare, solidificare, i risultati ottenuti, ma anche in quelle condizioni irreversibili e/o croniche entro le quali svolge una importante funzione di contenimento e tutela (patologie degenerative ecc. ), anche per coloro che le vivono indirettamente. In tale dinamica, nonché in generale, dunque, l’obbiettivo dell’intervento è il miglioramento della qualità di vita dell’individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni, di salute e di disagio, nelle quali ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autonomia e autodeterminazione, e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse disponibili o da attivare, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente. Al contempo, lo psicologo realizza interventi diretti e mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva e interpersonale, pertanto incrementando anche la capacità di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio psichico o disabilità.
Benché, lo psicologo che non sia specializzato e abilitato alla psicoterapia (attività rivolta alla risoluzione dei sintomi, e delle loro cause, conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, sofferenze) non può trattare disturbi psicologici o psichiatrici (che variano dai gravi disturbi legati alla sfera del pensiero ai disturbi d’ansia) e, non essendo un medico, non può prescrivere farmaci. Indi per cui in presenza di un disagio soggettivo che non comporta una sintomatologia invalidante può essere utile richiedere inizialmente una consulenza psicologica (o counseling), cosicché, mediante l’ascolto, l’osservazione, la definizione del problema e la valutazione, l’empowerment, necessari alla formulazione dell’eventuale, successiva, diagnosi, il clinico può valutare la natura della problematica e suggerire adeguati percorsi di trattamento: una consulenza psicologica al fine di sostenere, alleviare le condizioni di disagio e di sofferenza, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, mediante tutte quelle attività e quegli strumenti caratterizzanti la professione psicologica (la relazione terapeutica, il setting, l’ascolto attivo, la parola, l’empatia ecc.), orientata a promuovere un cambiamento e a raggiungere gli obiettivi dell’intervento psicologico, qualora il disagio o il problema non configuri quale sintomo di un disturbo psicopatologico; una psicoterapia e/o una consulenza psichiatrica qualora il disagio si configuri quale disturbo psichico con sintomi più o meno severi.
Nondimeno, qualsiasi evento può avere un forte impatto sulla nostra vita, infatti, è anche l’interpretazione che ne diamo a determinare una valenza negativa o positiva. Ogni evento avrà per noi un significato soggettivo, non opinabile e personale, spesso anche inconsapevole. In realtà molti si rivolgono allo psicologo al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento. Ma anche per affrontare un lavoro su se stessi, come momento non necessariamente dettato da un grave dolore o dalla rielaborazione del passato, mossi da un bisogno di conoscenza profondo, dalla voglia di mettersi in discussione e cambiare alcuni lati spigolosi del proprio Sé, favorendo la consapevolezza, l’apprendimento e lo sviluppo a lungo termine con un appropriato livello di analisi. Oppure per discutere con un interlocutore neutrale e affidabile ma al contempo empatico, sensibile e professionale. Infatti, uno degli aspetti che coinvolgono la vita professionale dello psicologo, oltre alla gestione dello stress, è sicuramente la necessità di gestire le proprie emozioni. Agli psicologi, dunque, è richiesta una competenza tecnica mediata da una forte componente relazionale. Cosicché l’attenzione sostenuta, l’ascolto empatico e la presenza emotiva, diventano dimensioni importanti del colloquio, attraverso anche il linguaggio non verbali: una modalità di comunicazione meno controllabile e più spontanea, elementi chiave per ‘accedere’ e ‘interagire’, in un clima di fiducia e rispetto. Nonché, importanti fattori dell’alleanza terapeutica. Secondo Lowen, l’individuo parla più chiaramente con il movimento, con la postura, con l’atteggiamento mimico e prossemico che con le parole, esprimendosi in un linguaggio che anticipa e trascende l’espressione verbale. Infatti, attraverso il linguaggio non verbale o CNV (comunicazione non verbale) avviene una trasmissione d’informazione mediata da strumenti d’iterazione diversi da quelli previsti dal linguaggio verbale, parlato o scritto, che comprendono, pertanto, una vasta serie di indicatori di tipo cinesico, prossemico, paralinguistico, cronemico ecc. D’altro canto, come suggerisce Elkaim (1996) “[…] Lo psicologo dovrà esaminare le proprie risonanze, definite come intersezioni di elementi comuni a diversi individui o sistemi umani, che gli permettono di cogliere una costruzione o realtà comune con il suo interlocutore”.
Riservatezza sui dati relativi all’utente

Rispetto del segreto professionale (art.622 codice penale). Ulteriormente, suddetto articolo del codice penale vieta anche di fornire informazioni sui nomi degli utenti seguiti. In caso di relazioni scientifiche e ricerca tutela l’anonimato dell’utente. In particolare, deroga dal segreto professionale solo:
- A. su autorizzazione dell’utente (ma prestando comunque attenzione alla sua tutela psicologica;
- B. in caso di collaborazione con altri soggetti tenuti al segreto professionale (ma condividendo con loro il minimo indispensabile);
- C. in caso di obbligo di referto o denuncia;
- D. per evitare pericolo di vita o di salute dell’utente o di altri;
- E. l’obbligo di testimonianza davanti al giudice non sussiste quando lo psicologo svolge la propria attività con tossicodipendenti in qualità di dipendente pubblico o di dipendente di enti convenzionati con enti pubblici (Art. 120.c. del D.P.R. 309/1990), né negli altri casi (vedi comma.1.d. dell’art. 200 del codice di procedura penale: “sono esentati dall’obbligo di testimonianza […] gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale”.
Infine, tutela la segretezza dei propri appunti, registrazioni, archivio, anche in caso di impossibilità o impedimento e quando deve immagazzinare i dati dell’utente in ‘sistemi di documentazione’ (sistemi informatizzati ecc.) gestiti da altri soggetti.
Normativa sulla privacy
Il D. Lgs. 196/2003 tutela la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a terzi di dati personali. In particolare i dati personali possono essere utilizzati, trattati e conservati solo per gli scopi, per il tempo e con i modi autorizzati dall’interessato. Ovverosia solo se il cliente sottoscrive, al momento del conferimento dell’incarico professionale, una dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati personali, inclusi quelli che la legge definisce ‘sensibili’ (razza o etnia, ad eventuali adesioni a partiti, organizzazioni a carattere religioso, politico, associazioni di categoria, nonché dati personali idonei a ricavare lo stato di salute e la vita sessuale del singolo).
Approfondimento sulla prestazione psicologica (Codice Deontologico)

Il Codice Deontologico completa quanto previsto dall’art.2229 del codice civile, in particolare esso illustra principi e norme di condotta nelle aree critiche dell’attività dello psicologo. La necessità di un codice deontologico è spiegata al suo interno: lo psicologo interviene significativamente nella vita degli altri, per tale motivo deve evitare di utilizzare la sua influenza contraria agli interessi del cliente, identificato come il destinatario dell’intervento psicologico o della psicoterapia. In particolare, alcuni dei temi principali riguardanti tale figura che ricorrono nei vari articoli sono i seguenti:
- utilizzo esclusivo di metodologie scientifiche nella prestazione;
- mantiene un adeguato livello di preparazione;
- usa solo strumenti che padroneggia e non li utilizza in modo improprio;
- non arreca danni agli utenti;
- interrompe attività che non portano miglioramento all’utente;
- rispetto per la dignità dell’utente, cioè non trattare l’utente come inferiore, quindi riduce la disparità originata dalla differenza di ruoli;
- rispetta la dignità, il diritto all’autodeterminazione, all’autonomia e alla riservatezza dell’utente;
- promozione dell’autodeterminazione dell’utente;
- aiuto agli utenti a sviluppare autonomia e consapevolezza, nonché propri giudizi, opinioni e scelte;
- rispetta opinioni e credenze di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori;
- non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, identità di genere di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità dell’utente;
- evita l’uso non appropriato della propria influenza, ad esempio per assicurare a sé o ad altri vantaggi indebiti;
- non avalla col proprio titolo professionale attività ingannevoli;
- esplicita il suo compenso e all’inizio della prestazione;
- evita di svolgere attività extraprofessionali che possano portare vantaggi materiali dagli utenti diversi dal compenso pattuito;
- sono vietati compensi diversi dal corrispettivo per prestazioni professionali;
- evita di svolgere attività professionale con persone con cui ha intrattenuto o intrattiene relazioni personali, affettive o sessuali ed evita relazioni personali, affettive o sessuali con gli utenti;
- evita peraltro vantaggi personali da colleghi in supervisione e tirocinanti;
- rispetta la libertà di scelta dell’utente riguardo a professionisti e strutture di cura e diagnosi a cui rivolgersi;
- pubblicizza i propri servizi in maniera trasparente e veritiera;
- promuove l’adesione ai principi deontologici;
- sostiene autonomia intellettuale dei colleghi;
- non dà pubblicamente giudizi negativi su colleghi, piuttosto informa l’Ordine;
- rimanda ad altri colleghi i casi che non è in grado di trattare;
- evita condotte eccentriche che possano screditare la professione;
- evita comportamenti scorretti per assicurarsi e guadagnare clientela;
- ottiene il nulla osta dell’Ordine per la propria pubblicità;
- contrasta l’abusivismo e lo segnala all’Ordine;
- condivide i progressi delle proprie tecniche e conoscenze.
Fonti e letture consigliate
- V. Girotti & M. Zorzi, Manuale di psicologia generale (2016).
- R. Revlin, Psicologia cognitiva (2014).
- P. Legrenzi & L. Anolli, Psicologia generale (2012).
- P. Gray, Psicologia (2012).
- N. Deal & M. Mortillaro & K. Scherer, Emotion Expression in Body Action and Posture (2011).
- A. Lowen, Il linguaggio del Corpo (2007).
- M. Elkaim, Dall’autoreferenzialità alle aggregazioni (1996).
- C.G. Jung, Praxis der Psychotherapie (1971).
- A. Triglia & B. Regader & J.G. Allen, Che cos’è l’intelligenza? (2018).
- N. Jar, Comunicazione non verbale (2018).
- N. Berardi & A. Sale, Ambiente, plasticità e sviluppo cerebrale (2019).
- J.M. Urena Bares & E. Urena Bares, Il cervello loquace (2019).
- F. Caruana, Il cervello empatico (2019).
- A. Cordella & B. Grasso & R. Pennella, Metodologia dell’intervento in psicologia clinica (2015).
- R. Pennella & B. Cordella, Costruire l’intervento in psicologia clinica. Riflessioni teoriche ed esperienze cliniche (2007).
- D. Giovannini, Colloqui psicologico e relazione interpersonale (1998).
- A. Lis & P. Venuti & M.R. Zordo, Il colloquio come strumento psicologico (1991).
- G. Trentini, Manuale del colloquio e dell’intervista (1995).
- A. Quadrio, Il colloquio in psicologia.
- F. Perussia, Psicologo: Storia e attualità di una professione scientifica (1994).
- M. Lang & F. Del Corno, Elementi di psicologia clinica (2005).
- U. Fornari, Trattato di psichiatria forense (2013).
- A.P. Ercolani & A. Areni & L. Leone, Elementi di statistica per la psicologia (2008).
- C. Chiorri, Fondamenti di psicometria (2010).
- L. Picone & L. Pezzuti & F. Ribaudo, I test nella pratica clinica. Uso ed interpretazione (2013).
- M. Robert, La ricerca scientifica in psicologia (2002).
- Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.