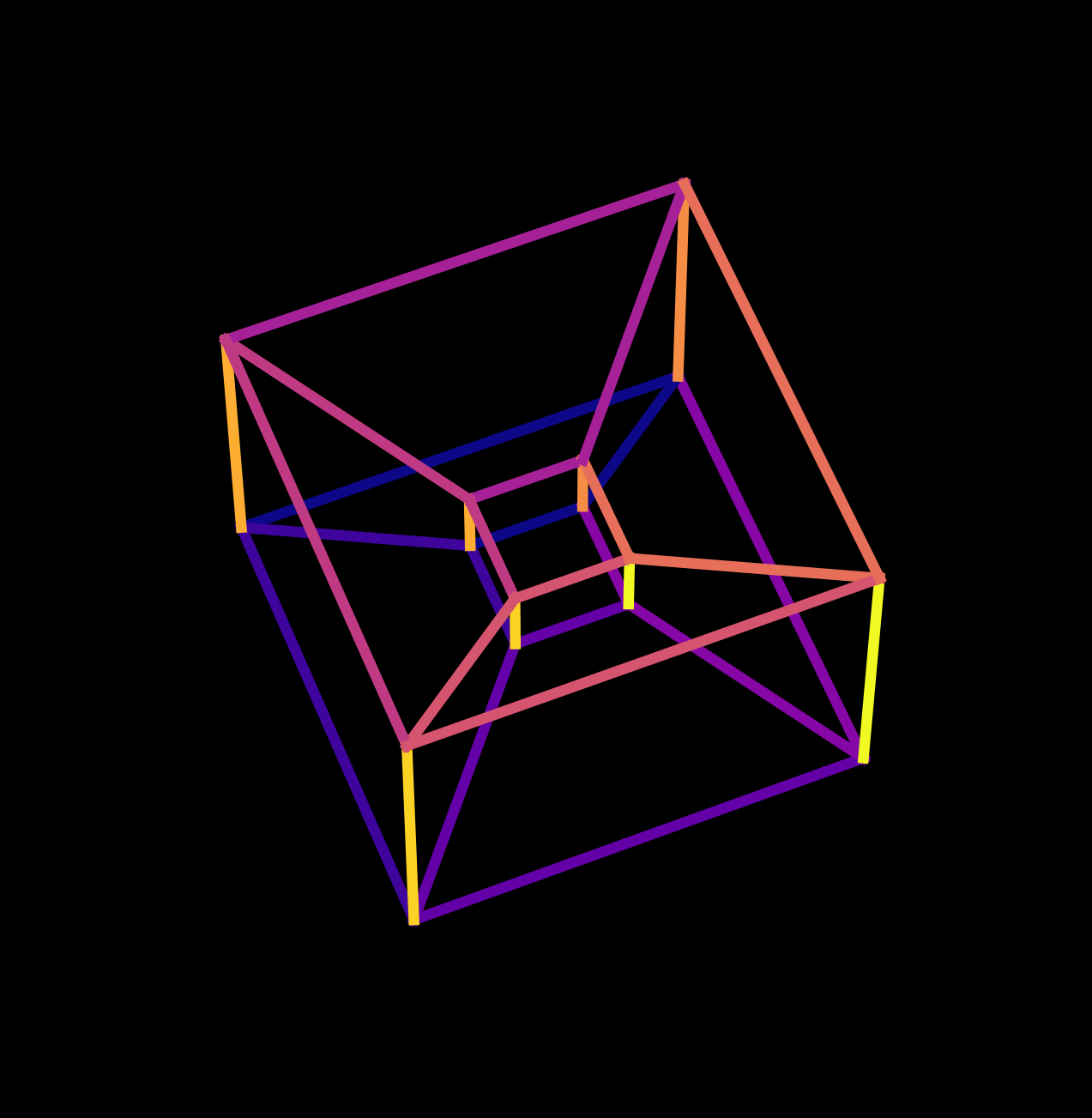Identità sessuale
Introduzione
Il termine indica un insieme di elementi, che sono parte fondamentale della comprensione profonda che ciascuno di noi ha di se stesso, come essere umano sessuato. Interrogarsi su di essa vuol dire porsi di fronte alla domanda sul proprio essere maschi o femmine. La natura complessa dell’argomento, data anche dall’incertezza e imprevedibilità di molti suoi costituenti, essendo l’esito di un processo costruttivo influenzato dalla vasta interazione tra aspetti biologici, psicologici, educativi e socioculturali, ne pone l’esigenza di classificazione e stabilità.
Formalmente, numerosi autori, tra cui in primis Shively e De Cecco (1977) la definiscono come la dimensione individuale e soggettiva del proprio essere sessuati, vista come un costrutto multidimensionale, e ne distinguono quattro componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale.
Sesso biologico
Il sesso biologico può essere, forse, il concetto più intuitivo in questo calderone di termini. Secondo Giannini Belotti (1980), esso“[…]viene determinato dalle caratteristiche fenotipiche che contraddistinguono la funzione riproduttiva degli individui: organi sessuali interni e esterni e i livelli ormonali, tra maschi e femmine.” Infine, appare importante sottolineare che Migeon et all. (2002)elaborarono un modello, pensandolo come frutto dell’interrelazione di varie componenti: sesso cromosomico, sesso gonadico, sesso ormonale, sesso fenotipico, e sesso cerebrale.
- Sesso cromosomico o genetico: ha origine genetica e consiste nei cromosomi sessuali e geni tramandati dai genitori, determina il genotipo sessuale del feto: 46,XX femmina, 46,XY maschio o altre varianti (intersessuale).
- Sesso gonadico: viene stabilito dalla presenza delle gonadi femminili (ovaie) oppure maschili (testicoli). Conseguente dal sesso cromosomico, in particolare ha origine dall’intreccio dei cromosomi XX e XY, in quanto il gene responsabile a tale differenziazione è l’SRY del cromosoma Y.
- Sesso ormonale: è derivante dai rilasci di ormoni LH e GnRH dall’ipotalamo, che agiscono sulle gonadi. Queste sintetizzano gli ormoni in estrogeni oppure androgeni, implicando la femminilizzazione o mascolinizzazione dei tessuti.
- Sesso fenotipico: consiste nella presenza o, laddove, in assenza dei caratteri secondari, dei genitali esterni e nell’aspetto esteriore dell’individuo. Includendone anche i genitali interni: determinati dalle gonadi e dai canali ad essi collegati. Alla luce di ciò, i dotti Mulleriani originano le tube di Falloppio, l’utero e la porzione posteriore della vagina. I dotti di Wolf originano l’epididimo, i vasi deferenti e la vescicola seminale.
- Sesso cerebrale: consiste nelle differenze anatomiche tra cervello maschile e femminile in merito ai circuiti nervosi, ai comportamenti, alle capacità cognitive. Per concludere, Allen, Richey, Chai & Gorsky (1991) hanno riscontrato che le capacità cognitive potrebbero essere influenzate dal corpo calloso, ovvero un fascio di nervi che collega gli emisferi, in quanto nei due sessi si presenta come forma differente.
Identità di genere
“Il senso che abbiamo nel nostro sesso, di essere maschio nei maschi e di essere femmina nelle femmine” Stoller (1979). Questo concetto si colloca su un livello molto differente rispetto a quello del sopra citato “sesso biologico”. La più evidente di tali differenze consta nel fatto che, semplificando, il genere e la costruzione di una relativa identità come processo dinamico sono concetti determinati, esclusivamente, da variabili psicologiche e socioculturali. Mentre, il secondo è in qualche modo oggettivo, poiché determinante dalla biologia.
Lo psicoanalista Robert Stoller (1968) e il sessuologo John Money et all. (1972) furono i primi a coniare e usare nel linguaggio di ogni giorno la terminologia “identità di genere”. Brevemente, per “genere” s’intende l’aderenza e la vicinanza di un individuo alla definizione che culturalmente viene data di maschio o femmina, ossia l’esperienza interiore di tale costruzione ne definisce la sua identità. In altre parole, si può dire che il genere, secondo una celebre definizione della filosofa americana Judith Butler, è una copia di cui non esiste l’originale: ciascun essere umano, in qualsiasi contesto socioculturale sia inserito, riceve una serie di indicazioni, implicite ed esplicite, più o meno rigide, su che cosa sia appartenente al genere maschile e che cosa sia invece appartenente al genere femminile e vi si relaziona in cerca di somiglianze e differenze con ciò che sente. Infine, Lichtenberg (1989) sottolinea che tra i diciotto e i ventiquattro mesi, l’identità di genere è probabilmente stabilita in maniera salda e immutabile, e a partire dai tre anni i bambini sviluppano guide interne per seguire il range di comportamenti precedentemente rinforzati.
Come andremo ad esaminare, ricordiamo che l’identità di genere e l’orientamento sessuale sono due componenti distinte che compongono l’identità sessuale di un individuo.
Ruolo di genere
Il processo di apprendimento del ruolo di genere si consolida tra i tre e i sette anni, configurandosi come fase in cui le bambine e i bambini acquisiscono la coscienza di ciò che è tipicamente maschile e femminile. Per quanto concerne tale termine s’intende l’insieme delle aspettative sociali su ciò che è considerato adeguato ed appropriato per uomini e donne. In altre parole, se l’identità di genere è l’esito di un processo di appropriazione soggettiva che ciascuno di noi compie rispetto al proprio essere maschile e femminile. Il ruolo di genere è l’insieme delle “prescrizioni” e aspettative che la cultura di riferimento indica o impone, su ciò che ritiene consono nei riguardi di una donna e di un uomo, in particolare riferendosi ai modi, ai comportamenti e ai tratti della personalità che la società, la cultura ed il periodo storico ha stabilito come mascolini o femminini.
Parafrasando, in un certo qual modo, si può affermare che l’identità di genere è l’esperienza privata del ruolo di genere, mentre il ruolo di genere è l’espressione pubblica dell’identità di genere. Ossia due facce della stessa medaglia. Giacché come nel linguaggio teatrale, il ruolo di genere non è semplicemente un pezzo di carta presentato da un attore, ma un ruolo incorporato nell’attore, il quale, trasformato da questo, lo incorpora e lo manifesta attraverso se stesso.
Concludendo, come disse Priulla (2013), i ruoli sociali hanno retaggi antropologici legati alla biologia umana, alla struttura fisica e alla funzione generatrice femminile come agli ideali patriarcali dalla quale discende la cultura contemporanea. E tutti coloro i quali non rispettano i ruoli sanciti dall’appartenenza al proprio sesso vengono stigmatizzati.
Orientamento sessuale
In ultima istanza, a completare il quadro dell’identità di un individuo vi è l’orientamento sessuale, secondo l’American Psychological Association (2008) lo definisce come la tendenza stabile a sentirsi attratto dal punto di vista affettivo-emozionale, sentimentale e/o sessuale verso uno o più sessi. Si individuano, inoltre, orientamenti sessuali diversi dall’eteronormatività sociale, finalizzata alla sopravvivenza della specie attraverso l’atto riproduttivo.
Metaforicamente può essere rappresentato come una bussola che indica la direzione sentimentale e/o erotica. Chi è portato verso persone del proprio sesso, come chi è portato verso persone dell’altro sesso, può scegliere se contrastare questa direzione e con quale modalità farlo, se comunicare tale direzione ad altri, ma non può scegliere la specifica direzione della bussola. Inoltre risulta alquanto semplicistico ridurre l’orientamento sessuale su un contiuum che va dall’eterosessualità all’omosessualità passando per la bisessualità. Sarebbe più corretto considerarlo come un costrutto multidimensionale in cui convergono molti fattori: comportamento sessuale, attrazione, fantasie sessuali, preferenze sociali ed emotive, autoidentificazione e stile di vita. Indi per cui possono esistere, ad esempio, differenze tra i comportamenti e le fantasie o tra innamoramento e attrazione. Ossia come afferma, sempre Graglia (2009), ci si può eccitare davanti a scene omosessuali, tuttavia innamorarsi solo di persone dell’altro sesso. In ultima analisi l’orientamento sessuale di ciascun individuo, può anche mutare più volte nel corso della vita, lo si deve considerare come un processo di costruzione dinamico, non immutabile, che si verifica nel corso di tutta l’esistenza.
Fonti e letture consigliate
- Comprendere la differenza: verso una pedagogia dell’identità sessuale. Armando Editore. F. Batini (2011).
- Components of sexual identity. Journal of Homosesexuality. M.G. Shively & J.P. De Cecco (1977).
- Ambiguous Genitalia With Perineoscrotal Hypospadia in 46XY. Individuals: Long-Term Medical, Surgical and Psycho Sexual Outcome. Migeon et all. (2002).
- Sex differences in the corpus callosum of the living human being. Journal of Neuroscience. L.S. Allen, M.F. Richey, Y.M. Chai & R.A. Gorski (1991).
- La storia di Miss Belle. Roma: Laterza. R. Stoller (1979).
- Sex and gender. New York: Science House. R. Stoller (1968).
- Man & Woman, boy & girl: differentiation and dimorphism of gender identity from conception in maturity. Johns Hopkins University Press, Baltimora. J. Money & A.A. Ehrhardt (1972).
- Psicoanalisi e sistemi motivazionali. Milano: Cortina. J.D. Lichtenberg (1989).
- The history of the concept gender identity disorder. Zeitschrift fur Sexualforschung. J. Money (1994).
- C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole. Milano: Franco Angeli. G. Priulla (2013)
- http://www.apa.org//helpcenter/sexual-orientation.aspx American Psychological Association (2008).
- Psicoterapia e omosessualità. Roma: Carocci Faber. M. Graglia (2009).
- The bisexual Option. Binghamton, NT: Haworth Press. F. Klein (1993).