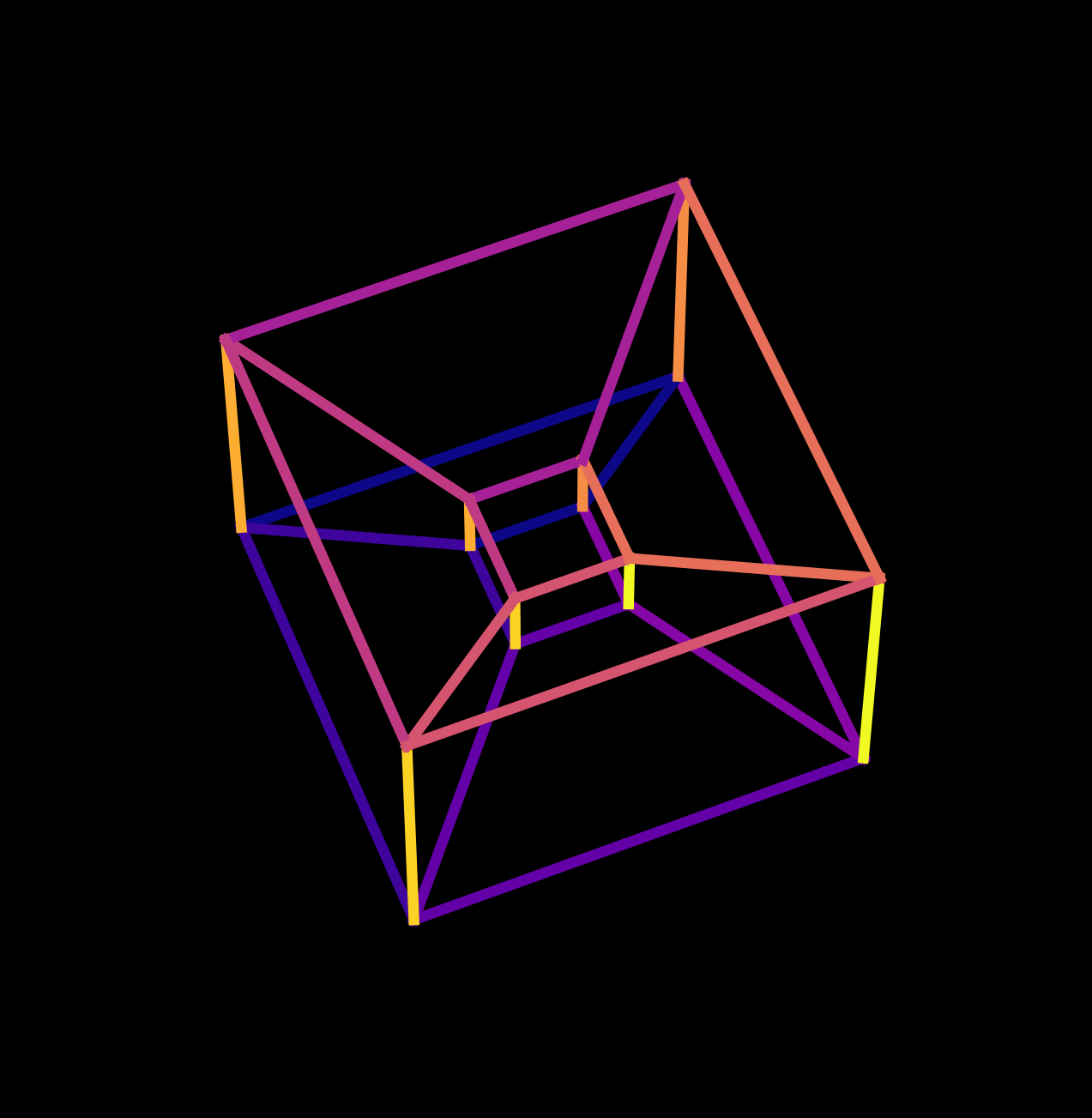Tra stereotipi di genere e realtà
“Non si trova mai se stesso finché non ci si relaziona con la -realtà-, e la mia realtà ha bisogno dell’immaginazione come un cieco del suo bastone, ma, l’immaginazione ha bisogno della realtà come un diodo della sua corrente”
Filosofi e scienziati dibattono spesso riguardo la natura della realtà e della sua interpretazione. Nonostante in entrambi, come in ciascun individuo, l’interpretazione che ne viene fornita si basa non solo sulle percezioni che si ha di ciò che ci circonda, ma anche sulle categorizzazioni che si è precedentemente generato dell’ambiente. Sebbene in ogni epoca, la sua comune rappresentazione sia governata da un certo insieme di presupposti indiscussi ed insospettati. Un possibile primo passo per una sua comprensione è prendere consapevolezza, valutando alcuni aspetti, di come essa prende forma nella nostra mente. Tuttavia, sebbene non ci sia realtà permanente ad eccezione della realtà del cambiamento, poiché la permanenza è un’illusione dei sensi, la mente umana è protesa a cercare scorciatoie per avvicinarsi di più al principio del risparmio energetico. Decodifica e classifica i nuovi eventi e le nuove informazioni con categorie mentali prestabilite, culturalmente e socialmente apprese. Ognuno percepisce ciò per cui è preparato e predisposto a percepire. La cosiddetta euristica della disponibilità ci spiega come la nostra mente non tende a costruire nuove forme mentali per ogni nuova informazione, ma tende a utilizzare quelle già precedentemente esistenti per l’interpretazione e la percezione delle nuove informazioni. Anche l’euristica della rappresentatività aiuta la mente a trovare scorciatoie per classificare eventi, oggetti ed individui, impiegando stereotipi e somiglianze. In altri termini, tendiamo a valutare un nuovo evento sulla base di esempi concreti simili che ci vengono in mente. Le categorie, che costituiscono la nostra forma mentis, costruite sulla base delle esperienze pregresse, tendono ad essere piuttosto rigide, poco duttili, poco malleabili e modificabili. Pertanto alcune informazioni contenute in esse, essendo maggiormente radicati nell’individuo, assumono un carattere di assolutezza, con la conseguente perdita della realtà che contraddicono la realtà stessa. In tal senso, può accadere, la tendenza per cui elementi della realtà che contraddicono un’aspettativa relativa a uno specifico fenomeno tendono ad essere ignorati, per permettere il mantenimento del fenomeno stesso. (Per approfondimenti: “Bias”).
Una delle categorie più rigide e tendenzialmente più stabili e radicate, è costituita dalla dicotomia di genere, ossia dalla differenziazione binaria uomo/donna. Dove tra gli aspetti più rilevanti troviamo, il concetto di stereotipo di genere inteso come credenza semplificata che viene esplicata a specifiche categorie di soggetti e rappresenta il nucleo soggettivo del pregiudizio, ossia un giudizio di valore assunto a priori che è in grado di dirigere l’azione sotto forma di pratiche più o meno intense e esplicite di discriminazione. In particolare, essi sono come dei processi di astrazione e di definizione della realtà che collegano e indirizzano una o un gruppo di caratteristiche a una classe o gruppo sociale, sulla base di una limitata e insufficiente informazione o conoscenza. Quindi mettendo a fuoco gli aspetti più salienti e articolando intorno ad essi tutto il resto, si lascia nell’ombra gli elementi che porterebbero a una disconferma dell’immagine di base. Dunque gli stereotipi di genere influenzano profondamente il pensiero collettivo, riempiendolo di contenuti specifici, di convinzioni e di idee in relazione alla concezione di ciò che è considerato maschile e femminile. Pertanto detengono una funzione significativa nello sviluppo della personalità e delle relazioni sociali, dacché agiscono su alcune componenti dell’identità sessuale di un individuo, quali il ruolo e l’orientamento. Come ad esempio, in rapporto alla condotta dei maschi e delle femmine, ovvero i primi ” non sono timorosi, appaiono forti, impavidi e determinati “, mentre le seconde ” appaiono dolci, timorose e sensibili”. Oppure ancora, soggetti che mostrano “tratti” del sesso opposto vengono definiti gay o lesbiche. Ne segue che gli stereotipi proprio per la loro rigidità, per il modo in cui vengono costruiti, condizionano lo sviluppo dell’identità sessuale di un soggetto, in quanto ne limitano l’esplorazione e la plasticità nella definizione. Nonché finiscono pertanto con il cristallizzare l’immagine di una realtà che è invece in movimento.
Il concetto di stereotipo ha la sua culla nella psicologia sociale, benché il primo ad utilizzare tale termine sia stato Lippmann (1922), un giornalista, nel suo volume “L’opinione pubblica”. Mentre, tra i primi ad affrontare nello specifico tale tema sono stati Sheriffs e Jarrett (1953) e in seguito Sheriffs e Mckee (1957), i quali hanno cercato di individuare le credenze condivise e le diverse caratteristiche attribuite rispettivamente a uomini e donne. Gli studi successivi, seppur a distanza di diversi anni e a fronte di profondi mutamenti sociali, hanno mostrato poi una fondamentale invarianza rispetto a quei primi dati raccolti (Spence e Helmreich nel 1978, Diekman e Eagly nel 2000). Molti studi, effettuati da diversi ricercatori, sui tratti che differenziano le personalità di donne e uomini evidenziano una sostanziale uniformità tra gli attributi associati, sia dagli uomini che dalle donne, rispettivamente a uomini e donne. Per lo stereotipo maschile risultano gli aggettivi: dominante, aggressivo, competitivo, indipendente, ambizioso, sicuro di sé, avventuroso e decisionista; mentre per lo stereotipo femminile: affettuosa, remissiva, emotiva, empatica, loquace, gentile.
| Aggettivi associati agli uomini | ||
| (tratto da Williams & Bennett, 1975) | ||
| Affermativo | Disordinato | Indipendente |
| Aggressivo | Dominante | Logico |
| Ambizioso | Elegante | Maschio |
| Autocratico | Difficile | Crudele |
| Avventuroso | Energico | Razionale |
| Rumoroso | Giocoso | Realistico |
| Rischioso | Intraprendente | Rigoroso |
| Fiducioso | Grossolano | Robusto |
| Costante | Forte | Appassionante |
| Coraggioso |
| Aggettivi associati alle donne | ||
| (tratto da Williams & Bennett, 1975) | ||
| Amorevole | Fresca | Piagnucolona |
| Attenta | Umile | Interessata |
| Attraente | Emotiva | Prudente |
| Capricciosa | Eccitabile | Sognatrice |
| Affascinante | Bassa | Sentimentale |
| Incantatore | Donne | Delicata |
| Compiaciuto | Frivola | Sofisticata |
| Delicata | Nervosa | Loquace |
| Dipendente | Perseverante |
Essi vengono ricondotti, di volta in volta, ai binomi “communal and agentic” (autonomia, attivismo vs. sollecitudine, capacità di prendersi cura degli altri), “strumentale-espressivo” (orientato al risultato, all’azione manuale vs. capace di esprimere sentimenti, supportiva) o semplicemente “maschile-femminile”. Uno studio di Diekman e Eagly (2000) ha individuato alcuni degli aspetti che definiscono quattro dimensioni degli stereotipi di genere: di personalità positivi (es. coraggioso vs. sensibile), cognitivi (es. analitico vs. intuitiva), fisici (es. vigoroso vs. fragile), di personalità negativi (es. arrogante vs. petulante).
Sulla base di stereotipi di genere, molteplici sono i casi di comportamenti discriminatori, per quanto punibili penalmente, nei confronti delle donne e degli uomini. Tra i più frequenti vi sono quelli legati alla sfera occupazionale per cui, ad esempio le donne non vengono ritenute idonee a svolgere determinate mansioni. Allo stesso modo, a causa delle reali o presunte esigenze di conciliazione con la famiglia, in quanto ad esse viene attribuita una maggiore propensione alla cura familiare, si riscontrano spesso casi di discriminazione rispetto all’opportunità di crescita professionale. Inoltre sia uomini che donne a seguito dell’influenza degli stereotipi sembrano auto-limitarsi, il cosiddetto fenomeno dello “Stereotype Threat”, ovvero la minaccia associata ad esso, per cui un soggetto, appartenente a un gruppo stereotipato e al quale tale stereotipo viene attribuito, porterà una performance inferiore rispetto a quella in una condizione di controllo. In altre parole, se alle donne vengono attribuite minori capacità matematiche e agli uomini minor capacità dialettiche, i punteggi in prova di abilità matematica o linguistica seguiranno le previsioni dello stereotipo a cui i soggetti sperimentali erano stati esposti.
Particolarmente fecondo, ad oggi, è l’argomento che analizza il processo di trasmissione degli stereotipi attraverso i media. Come ad esempio, tramite le immagini pubblicitarie, le trasmissioni a vario titolo, la diffusione dell’opinione di personaggi pubblici, i mass-media e i social-media, poiché essi possono diffondere e consolidare o contribuire i modelli stereotipati. In particolare sono oggetto d’interesse e attento monitoraggio le proposte mediatiche indirizzate ai bambini, quali, gli albi con favole, I libri scolastici, i cartoni animati, le pubblicità di giocattoli.
In conclusione, dopo decenni di discussioni, quel che emerge in termini di differenza statisticamente significativa, scarsamente influenzata dall’educazione, è per le donne una maggiore capacità, in media, nelle abilità linguistico-verbali e altresì nella comunicazione non verbale specie a tonalità emotiva. Mentre per gli uomini una maggiore capacità in campi visuo-spaziali, come l’orientamento e la rotazione mentale di oggetti. Ancora nelle donne maggiore attitudine nell’immedesimazione empatico-affettiva e alla relazione affettiva (communion), inoltre una maggiore motilità manuale fine e rapida. Invece negli uomini la maggiore propensione al comportamento intraprendente (agency) e all’aggressività fisica, nonché le maggiori abilità motorie nel colpire oggetti, in quanto si ipotizzano collegamenti con la diversa dotazione ormonale: il testosterone sembra correlare con le abilità visuo-spaziali, oltre che con l’aggressività. Tuttavia, alcune di queste differenze sono più marcate in età giovanile, per poi attenuarsi col progredire degli anni. Poi, per quanto concerne le abilità matematiche e l’essere portati per le materie tecnico-meccaniche, secondo vari studi, le donne prevalgono nei test di calcolo numerico, dacché vi intervengono meno strategie implicanti abilità visuo-spaziali. Sebbene rimane l’enigma del perché gli adolescenti superdotati in matematica siamo quasi sempre maschi. Alla luce di quanto esposto, purtuttavia, ogni motivo di discriminazione pretestuosamente suggerito dalle differenze, innate o acquisite che siano, è esorcizzabile a condizione che le diverse doti siano apprezzate come aventi pari valore e che, inoltre, siano praticate dagli individui secondo le proprie inclinazioni. Ovverosia fuori da stereotipi ingabbianti secondo il sesso di appartenenza. La cultura per via di varie argomentazioni potrebbe ancora e sempre premiare le differenze, purché esercitate nella libertà dei singoli, in vista di un cammino di arricchente integrazione delle diversità.